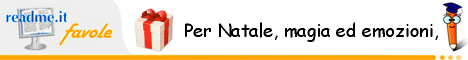home page
home page
 pagina iniziale
pagina iniziale
|

|
by
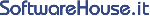
|


|
Ebook in formato Kindle (mobi) - Kindle File Ebook (mobi)
Formato per Iphone, Ipad e Ebook (epub) - Ipad, Iphone and Ebook reader format (epub)
Versione ebook di Readme.it powered by Softwarehouse.itPlatone
Eutidemo
Platone Eutidemo
2
Platone
EUTIDEMO
CRITONE: (1) Chi erao Socratequello con cui discutevi ieri nel Liceo? (2)Una grande folla vi stava intorno
tanto che iovolendo ascoltarvipur essendomi avvicinatonon riuscii asentire nulla di chiaro; tuttaviaprotendendo la
testariuscii a vedere e mi parve che fosse uno straniero quello con cuidiscutevi. Chi era?
SOCRATE: Di quale dei due chiedio Critone? Non c'era infatti una solapersonama ce n'erano due.
CRITONE: Quello di cui parlo io sedeva alla tua destrail terzo a partire date; in mezzo a voi c'era il ragazzo figlio
di Assioco. (3) E mi sembròo Socrateche fosse cresciuto moltissimo e chenon avesse molta differenza di età dal
nostro Critobulo. (4) Quello però è mingherlinoquestoinveceèprestante ed eccellente d'aspetto. (5) SOCRATE;
Quello di cui chiedio Critoneè Eutidemomentre quello seduto vicino ame a sinistra è suo fratello Dionisodoro: (6)
anch'egli prende parte alle discussioni.
CRITONE: Non conosco nessuno dei dueo Socrate. Come sembra sono nuovisofisti. Di che paese sono? E qual è
la loro sapienza? (7) SOCRATE: Costorocome credosono originari di Chio(8) o lì vicinoma emigrarono a Turi. (9)
Esiliati di là vivono in questi luoghi già da molti anni. Quanto a ciò sucui mi interroghila loro sapienzaè
meravigliosao Critone: sono veramente sapientissimi. Prima io non sapevoche cosa fossero i pancraziasti (10) perché
costoro sono perfettamente pronti ad ogni genere di combattimentoma noncom'erano i due fratelli pancraziasti
Acarnani. (11) Quei due infatti erano capaci di combattere solo col corpoquestiinvecesono in primo luogo fortissimi
fisicamente - essi sono molto abili a combattere in armi e sono in grado direndere tale un altro che paghi loro un
onorario -; in secondo luogo sono eccellenti nel combattere la battaglianelle aule di giustizia e nell'insegnare ad altri a
pronunciare e a scrivere discorsi adatti ai tribunali.(12) Primadunqueerano abili solo in questoora invece hanno
raggiunto la perfezione nell'arte del pancraziaste. Infatti ora hannopraticato un genere di battaglia rimasto intentato da
essisicché nessuno potrebbe assolutamente essere in grado di opporsi loro:talmente abili sono diventati nel combattere
nelle discussioni e nel confutare ciò che di volta in volta viene dettosiache sia falso sia che sia vero. PertantoCritone
ho in mente di affidarmi a questi due uominiperché dicono anche di poterrendere abile in questo stesso campo
chiunque altro in poco tempo.
CRITONE: Mao Socratenon temi l'etàdi essere cioè ormai troppovecchio?
SOCRATE: Niente affattoo Critone: ho una prova sufficiente e unincoraggiamento per non temereperché questi
stessi uominiper così direiniziarono da vecchi a dedicarsi a questasapienza che io desiderol'eristica; (13)l'anno
scorso o due anni fa non erano ancora sapienti. Ma io temo una sola cosadicoprire di discredito i due straniericome
Conno(14) figlio di Metrobioil citaristache mi insegna ancora oggi asuonare la cetra: quando mi vedono i ragazzi
miei condiscepoli mi scherniscono e chiamano Conno maestro di un vecchio.Temo quindi che qualcuno muova ai due
stranieri questo stesso rimprovero; e essitemendo ciòpotrebbero nonvolermi accettare. Ioperòo Critoneho
persuaso altri vecchi a frequentare la loro scuola come miei condiscepoli eora cercherò di persuadere altri. E tu perché
non la frequenti con me? Come esca per loro porteremo i tuoi figli: mirandoad essi so che istruiranno anche noi.
CRITONE: Nulla lo impedisceo Socratese così ti pare. Ma prima spiegamiquale sia la sapienza dei due uomini
affinché io sappia anche che cosa impareremo.
SOCRATE: Lo sentirai subitopoiché non potrei dire di non avere prestatoloro attenzioneanzi ne ho prestata molta
e ricordo bene e cercherò di esporti tutto dall'inizio. Per divinadisposizione stavo seduto là dove tu mi vedestida solo
nello spogliatoio e avevo già in mente di alzarmi per andarmene; malevatomisi manifestò il solito segnoquello del
demone.(15) Allora mi sedetti di nuovo e poco dopo entrarono questi due -Eutidemo e Dionisodoro - e insieme a loro
altri allievimoltimi parve. Entratisi misero a passeggiare nel vialecoperto. (16) E questi due non avevano ancora
fatto due o tre giriquand'ecco entrò Clinia che tudicendo la veritàaffermi essere molto cresciuto.
Dietro di lui moltissimi suoi ammiratori e tra gli altri Ctesippo(17) ungiovinetto del demo di Peania(18) molto
bello e buono per naturaper quanto arrogante a causa della giovinezza.Cliniadunquequando mi vide dall'entrata
seduto da solovenendo subito verso di mesì sedette alla mia destracomeanche tu dici.
Non appena Dionisodoro ed Eutidemo lo viderodapprimafermatisisi miseroa discutere tra di lorovolgendo di
tanto in tanto lo sguardo verso di noi - e io stavo molto attento ad essi -poi venuti da noi l'unoEutidemosi sedette
accanto al ragazzol'altro vicino a me a sinistragli altriinvececiascuno come capitava.
Li salutaidunqueperché li vedevo dopo molto tempo.
Dopo di ciò dissi a Clinia: «Cliniacerto questi due uominiEutidemo eDionisodorosono sapienti in questioni non
di pocama di molta importanza. Infatti conoscono tutto ciò che riguarda laguerraquanto è necessario a chi vuole
diventare un buon strategala disposizione delle schiereil comando deglieserciti e il combattimento in armi; ma sono
in grado anche di rendere un altro capace di difendersi nei tribunalisequalcuno gli fa ingiustizia».
Dopo avere pronunciato queste parole fui disprezzato da quei due: entrambiriseroguardandosi tra loroed
Eutidemo disse: «Non ci occupiamo più di questi argomentiSocratema litrattiamo come questioni secondarie».
Ed iomeravigliatodissi: «Il vostro lavorocredodovrebbe essere bellose per voi faccende così importanti sono
accessorie eper gli dèiditemi qual è questa bella occupazione».
«NoiSocratecrediamo di essere in grado di trasmettere la virtù meglio epiù rapidamente di tutti»rispose.
«O Zeusche dite!»esclamai. «Dove faceste questa felice scoperta?Pensavocome dicevo poc'anziche foste abili
per lo più nel combattimento in armi e questo dicevo di voi due. Quandoveniste qui la volta precedentericordo infatti
che facevate professione di questo. Ma se ora possedete davvero questascienza siatemi propizi: mi rivolgo a voi proprio
Platone Eutidemo
3
come a dèipregandovi di perdonarmi per le parole dette in precedenza. MabadateEutidemo e Dionisodorose dite la
verità: per la grandezza della vostra professione non c'è affatto dastupirsi se non vi si crede».
«Ma sappi beneo Socrateche è proprio così».
«Allora io vi consideroper il vostro possessomolto più felici del GranRe (19) per il suo potere. Ma ditemi se
avete in mente di mostrare questa sapienza o come avete deciso».
«Siamo qui proprio per questoo Socrateper mostrarla e per insegnarlasequalcuno vuole impararla».
«Ma vi garantisco che tutti quelli che non la possiedono vorranno impararlaio per primopoi Clinia qui presente e
oltre a noi Ctesippo e questi altri»dissiindicandoglì gli ammiratori diClinia che già stavano in cerchio intorno a noi.
Ctesippoinfattisi trovava seduto lontano da Clinia - mi parve cheEutidemodiscutendo con mesi piegasse in avanti
e impedisse a Ctesippo la vista di Clinia che si trovava in mezzo a noi - eCtesippodesideroso di vedere il suo amato e
nello stesso tempo di sentirebalzato in piediper primo si mise di frontea noi. Così anche gli altrivedendolosi
misero attorno a noisia gli innamorati dì Cliniasia i compagni diEutidemo e di Dionisodoro. Indicando appunto
questidicevo a Eutidemo che tutti erano pronti a imparare. Allora Ctesippofu prontamente d'accordo e così gli altri e
tutti insieme pregarono quei due di mostrare il potere della loro sapienza.
Allora dissi: «Eutidemo e Dionisodoroassecondate in ogni modo costoro eper amor mio mostratelo. è chiaro che
non è un'impresa da poco mostrarne la maggior partema ditemi questo: sepotete rendere buono solo un uomo che è già
persuaso che bisogna imparare da voio anche uno che non è ancora persuasoperché non crede affatto che la virtù si
possa imparare o che voi ne siate i maestri. Ma è compito della stessa arteo di un'altra persuadere chi la pensa così che
la virtù si possa insegnare e che voi siate coloro dai quali la si potrebbeimparare nel modo migliore?» «Di questa stessa
arteo Socrate»rispose Dionisodoro.
«Voidunque»dissi io«o Dionisodoromeglio di ogni altrocontemporaneo potreste esortare (20) alla filosofia e
alla cura della virtù?» «Lo crediamo proprioSocrate».
«Benerinviate ad altra occasione la dimostrazione del resto»dissi«mamostrateci questo: persuadete questo
ragazzo che bisogna filosofare e praticare la virtù e farete cosa gradita ame e a tutti costoro. La sua situazione è
all'incirca questa: io e tutti costoro desideriamo che diventi il migliorepossibile. è figlio di Assiocofiglio di Alcibiade
il Vecchio(21) cugino per parte di padre dell'Alcibiade oggi vivente: ilsuo nome è Clinia. è giovanee temiamo quindi
per luicom'è naturale per un giovaneche qualcuno ci prevengavolgendoil suo pensiero a un'altra occupazione e lo
corrompa. Voi duedunquesiete giunti a proposito. Se non vi spiacemettete alla prova il ragazzo e discutete davanti a
noi».
Dopo che ebbi detto press'a poco queste paroleEutidemo con coraggio eaudacia insieme disse: «Ma non ci spiace
affattoSocratepurché il giovinetto voglia rispondere».
«Ma certo»risposi«è anche abituato a questo: spessoinfatticostoroavvicinandosi a luigli fanno molte
domande e discutono con luicosicché probabilmente non teme dirispondere».
Come potrei poi esporti bene quanto avvenne in seguitoo Critone?
Non è impresa di poco conto incaricarsi di ciòesponendo una sapienzaindicibile; sicché iocome i poeti
nell'iniziare la narrazioneho bisogno di invocare le Muse e Mnemosine. (22)Eutidemodunquecredoiniziò
pressappoco così: «Cliniaquali sono tra gli uomini quelli che imparanoisapienti o gli ignoranti?».(23) E il ragazzo
poiché la domanda era difficilearrossì eimbarazzatoguardò verso dime. E ioaccortomi che era turbato«Coraggio
Clinia»dissi«rispondi senza paura in quale dei due modi ti sembra.Forse ciò ti reca un grandissimo vantaggio».
Intanto Dionisodoropiegatosi un po' verso il mio orecchiocon l'aspettomolto sorridente disse: «Ti preannuncioo
Socratechein qualunque dei due modi il ragazzo rispondasaràconfutato».
Ementre egli mi diceva queste paroleClinia risposecosicché non mi funeppure possibile avvertire il giovinetto di
stare attento: egli rispose che erano i sapienti quelli che imparavano.
Ed Eutidemo chiese: «Chiami alcuni maestri o no?». Ammise di sì. «Imaestri sono dunque maestri di coloro che
imparanocome il maestro di cetra e il maestro di scuola (24) erano senzadubbio maestri tuoi e degli altri ragazzie voi
inveceeravate allievi?». Assentì.
«Non è dunque vero che quando apprendevate non sapevate ancora ciò cheimparavate?». Disse di no. «Eravate
forse sapienti quando non sapevate queste cose?» «Certamente no»risposeegli.
«Dunque se non eravate sapientieravate ignoranti?» «Senza dubbio».«Voi alloraimparando ciò che non sapevate
imparavate essendo ignoranti». Il ragazzo annuì. «Perciò imparano gliignorantio Cliniae non i sapienticome tu
credi».
Dopo che egli ebbe detto queste parolecome un coro al segnale del maestroquelli del seguito di Dionisodoro ed
Eutidemo si misero nello stesso tempo ad applaudire e a ridere. E prima cheil giovinetto si riavesse per bene e a dovere
Dionisodorosubentrandodisse: «Mao Cliniaquando il maestro digrammatica vi dettavaquali bambini imparavano
le lezioni dettatei sapienti o gli ignoranti?» «I sapienti»risposeClinia. «Perciò imparano i sapienti e non gli ignoranti
e tupoco fanon hai risposto bene ad Eutidemo».
Allora gli ammiratori (25) dei due risero fragorosamente e applaudironoammirando la loro sapienza; noi altri
sbalordititacevamo. Eutidemoaccortosi che eravamo attonitiperché cimeravigliassimo ancora di più di luinon
lasciò in pace il ragazzoma continuò a interrogarlo ecome i bravimaestri di danzavolteggiò due volte (26) con le
domande sullo stesso punto e chiese: «Coloro che imparano imparano ciò chesanno o ciò che non sanno?». (27) E
Dionisodorobisbigliando di nuovo un po' con medisse: «Anche questadomandaSocrateè tale quale la precedente».
«O Zeus»esclamai«veramente anche la prima domanda ci sembrò bella».
Platone Eutidemo
4
«Socratenoi facciamo tutte domande insolubili simili a queste».
«Appunto per questo mi sembra che voi abbiate buona fama presso i vostriallievi».
Intanto Clinia aveva risposto a Eutidemo che coloro che imparavano imparavanociò che non sapevano. E quello lo
interrogò con gli stessi procedimenti di cui si era servito prima: «Ma nonconosci le lettere?»chiese. «Sì»rispose.
«Tutte?». Ammise di sì. «Alloraquando uno detta una cosa qualsiasinondetta delle lettere?». Riconobbe di sì.
«Perciò»disse«detta cose delle quali sai qualcosase le conoscitutte?». Ammise anche questo. «Ma allora»continuò
«non impari ciò che uno dettamentre impara chi non conosce le lettere?»«No»rispose«imparo io». «Allora»disse
«impari ciò che sai se conosci tutte le lettere». Ne convenne. «Non haidunquerisposto correttamente»concluse.
Eutidemo non aveva ancora finito di pronunciare queste parole che Dionisodoroprendendo la parola come una
pallaprese di nuovo di mira il ragazzo e disse: «CliniaEutidemo tiinganna.
Dimmiinfattiimparare non è acquistare scienza di ciò che uno impara?».
Clinia ammise di sì. «E Sapere»proseguì«è forse altro che averegià scienza?». Assentì. «Dunque non sapere è
non avere ancora scienza?». Fu d'accordo con lui. «Allora coloro cheacquistano una cosa qualsiasi sono quelli che la
possiedono già oppure quelli che non la possiedono?» «Quelli che non lapossiedono».
«Orbenehai ammesso che tra questiossia tra coloro che non hannoci sonoanche coloro che non sanno». Annuì.
«Perciò quelli che imparano sono tra quelli che acquistano e non tra quelliche possiedono?». Assentì. «AlloraClinia»
concluse«imparano quelli che non sanno e non quelli che sanno».
Poi ancora Eutidemo si lanciava contro il giovinetto per la terza voltaperabbatterlocome se si trattasse di una
lotta.(28) E ioaccortomi che il ragazzo stava soccombendovolendo darglirespiroaffinché non si spaventasse a causa
nostraconfortandolo dissi: «Clinianon meravigliarti se questi discorsiti sembrano strani.
Forse non comprendi che cosa fanno i due stranieri nei tuoi confronti: fannola stessa cosa che fanno quelli che
partecipano all'iniziazione dei Coribantiquando eseguono l'intronizzazione(29) nei confronti di quello che vogliono
iniziare. Infatti anche là ci sono una danza corale e un giocose veramentesei stato iniziato; e ora questi due non fanno
altro che danzare in coro intorno a te eper così direballare perscherzopensando di iniziarti dopo di ciò. Oradunque
pensa di ascoltare i primi riti sacri dei sofisti. In primo luogoinfatticome dice Prodico(30) bisogna imparare la
correttezza dei nomi. Ciò che appunto i due stranieri ti mostrano è che nonsapevi che gli uomini usano il termine
"imparare" quando unoche da principio non ha nessuna scienzariguardo a una cosain seguito l'acquisiscema lo
usano anche quando qualcunoche ha già la scienzaesamina con essa questastessa cosa fatta o detta: per questo si
servono del termine "comprendere" piuttosto che"imparare"ma talora anche "imparare". Tuinvecenon haiavvertito
come dimostrano costoroche lo stesso nome è dato a uomini che si trovanoin situazioni opposte: a chi sa e a chi non
sa. Simile a questo è anche il caso della seconda domandain cui tichiedevano se gli uomini imparano ciò che sanno o
ciò che non sanno. Questo genere di insegnamenti è un gioco - perciò tidico che costoro scherzano con te - e dico gioco
perchése anche qualcuno imparasse molte o anche tutte le nozioni similinon saprebbe affatto meglio come stiano le
cosema sarebbe solo in grado di scherzare con gli uominiabbindolandoli esconvolgendoli per mezzo della differenza
delle parolecome quelli che tolgono gli sgabelli di sotto a chi sta persedersi si divertono e ridonoquando lo vedono
caduto supino. Pensadunqueche questo ti sia stato fatto da costoro comescherzoma è chiaro che in seguito essi
stessi ti mostreranno gli insegnamenti serie io indicherò loro la viaaffinché mi diano ciò che mi avevano offerto.
Dicevanoinfattidi avere l'intenzione di mostrare la sapienza persuasiva;orainvecemi sembrahanno pensato di
dovere prima prendersi gioco dite. DunqueEutidemo e Dionisodorosia finitacon questi vostri scherziforse davvero
bastano; mostrate il seguitopersuadendo il ragazzo che bisogna prendersicura della sapienza e della virtù. Ma prima vi
mostrerò come intendo la cosa e come desidero ascoltarla. Se vi sembreràche lo faccia da incompetente (31) e in modo
ridicolonon deridetemi: infatti per il desiderio di ascoltare la vostrasapienza oserò improvvisare davanti a voi. Voi e i
vostri allievi sopportatemidunqueascoltandomi senza ridere. E tufigliodi Assiocorispondimi.
Tutti noi uomini non vogliamo forse stare bene? (32) O questa è una domandadi quelle che poco fa temevo fossero
ridicole? è certo insensato fare simili domandeperché chi tra gli uomininon vuole stare bene?» «Non c'è nessuno che
non lo voglia»rispose Clinia. «Bene»dissi. «Poidal momento chevogliamo stare benecome potremmo farlo? Forse
se abbiamo molti beni? O questa domanda è ancora più sciocca di quellaprecedente? è chiaroinfatticredoche anche
questo è così». Assentì. «Ma qualitra le cose che sonosono beni pernoi? O non sembra difficile e nemmeno proprio
di un uomo straordinario essere in grado di rispondere a questo proposito?Ognunoinfattici direbbe che l'essere ricco
è un bene. Non è vero?» «Certo»rispose. «Anche avere buona salute eessere belli ed essersi procurati adeguatamente
le altre doti fisiche?». Ne convenne. «Ma è chiaro che nobiltà dinascitapoteri e onori nella propria città sono dei beni».
Lo ammise. «Quale dei beni ci rimane ancora?»chiesi. «Che cos'èl'essere saggiogiusto e coraggioso? Per Zeus
Cliniapensi che giudichiamo rettamente se li consideriamo come benioppurese non li consideriamo beni? Forse
qualcuno potrebbe essere in disaccordo con noi. Ma a te come sembra?» «Chesiano beni»rispose Clinia. «Bene»
esclamai. «In che posto metteremo la sapienza? Tra i beni o come dici?»«Tra i beni».
«Bada che non tralasciamo qualche bene che sia degno di considerazione».
«A me sembra che non ne tralasciamo nessuno»rispose Clinia. E ioricordatomenedissi: «Sìper Zeusrischiamo
di tralasciare il più grande dei beni». «Di quale si tratta?»chieseegli. «Della buona fortunaCliniacosa che tutti
anche le persone molto ignorantidicono che sia il più grande dei beni».«Dici il vero!»esclamò. E iomutando di
nuovo pareredissi: «Per poco tu ed io non siamo diventati ridicoli difronte agli stranierio figlio di Assioco».
«Perché?»chiese. «Perchédopo avere considerato la buona fortuna neidiscorsi fatti in precedenzaora ne
parlavamo di nuovo».
Platone Eutidemo
5
«Perché?» «è certamente ridicolo riproporre ciò che è stabilito da unpezzo e dire due volte le stesse cose». «In che
senso?»chiese. «La sapienza è senza dubbio buona fortuna»risposi.«Lo saprebbe anche un bimbo». Ed egli si
meravigliò: è ancora così giovane e semplice! E ioaccortomi del suostuporedissi: «Non saiCliniache i suonatori di
flauto sono quelli che hanno miglior successo nel buon uso delle musiche perflauto?» Assentì.
«Quindi»proseguii«anche nella scrittura e nella lettura delle letterequelli che hanno miglior successo sono i
maestri di scuola?» « Certo». «E di fronte ai pericoli del marecrediforse che ci siano alcuni ad avere maggior successo
dei nocchieri espertiper dirla in generale?» «Nocerto». «E seprendessi parte ad una spedizione militarecon chi
condivideresti più volentieri il pericolo e la sortecon lo strategaesperto o con quello inesperto?» «Con uno stratega
esperto». «E se fossi malatocon chi affronteresti volentieri il pericolocon il medico esperto o con quello inesperto?»
«Con un medico esperto». «Forse»dissi«perché credi di trovartimeglio stando con un esperto piuttosto che con un
inesperto?».
Lo ammise. «La sapienzadunquefa sì che gli uomini abbiano buona fortunadovunqueperché essa non potrebbe
mai sbagliare in nullama è necessario che operi rettamente e siafortunataaltrimenti non sarebbe più sapienza».
Infine ci trovammo d'accordonon so comeche in generale la cosa stiacosì: quando è presente la sapienza chi la
possiede non ha affatto bisogno di buona fortuna; mapoiché ci eravamotrovati d'accordo su questogli chiesi di nuovo
come stessero per noi i punti ammessi in precedenza. «Avevamo ammesso»dissi«chese avessimo molti beni
saremmo felici e staremmo bene».
Assentì. «Saremmo felici a causa dei beni presentise non ci fossero pernulla utili o se ci fossero utili?» «Se ci
fossero utili»rispose.
«Ci sarebbero utili in qualche modo se li possedessimo soloma non liusassimo? Ad esempiose avessimo molti
cibima non li mangiassimooppure bevandema non le bevessimopotrebberoesserci utili?» «Nocerto»rispose. «E
tutti gli artigianise avessero pronto tutto il necessariociascuno per ilproprio lavoroma non lo usasserostarebbero
forse bene per il possessoperché avrebbero tutto ciò che un artigianodeve avere? Per esempioun falegnamese si
fosse preparato tutti gli strumenti adattima non lavorasse il legnopotrebbe trarre utilità dal possesso?» «In nessun
modo»rispose. «E se uno possedesse ricchezza e tutti i beni di cuiparlavamo poco fama non li usassesarebbe felice
per il possesso di questi beni?» «No di certoSocrate». «Bisognaquindi»dissi«come pareche chi vuole essere felice
non solo possieda tali benima li usi anchealtrimenti non gli derivanessuna utilità dal possesso». «Dici il vero».
«PerciòCliniaper rendere felice qualcunoè sufficiente possedere ibeni e servirsene?» «A me sembra di sì». «Forse»
chiesi«se uno se ne serve rettamenteoppure anche se non se ne serverettamente?» «Se se ne serve rettamente». «Dici
bene»risposi. «Infatti è peggiocredose qualcuno si serve di una cosaqualsiasi non rettamente che se la trascura: il
primo caso è un malel'altroinvecenon è né un male né un bene. O nondiciamo così?». Ne convenne. «Ma nella
lavorazione e nell'uso del legno ciò che realizza l'uso corretto è forsealtro che la scienza del falegname?» «Nocerto»
rispose.
«Ma anche nella lavorazione delle suppellettili quella che produce l'usocorretto è la scienza». Assentì. «Allora»
proseguii io«anche riguardo all'uso dei beni di cui parlavamo primaricchezzasalutebellezzal'uso corretto di tutti
questi era una scienza che guidava e dirigeva l'azione o qualcos'altro?»«Era una scienza»rispose. «Dunquecome
sembrala scienza procura agli uomini non solo buona fortunama anche buonuso in ogni possesso e azione». Fu
d'accordo. «Dehper Zeus»dissi«c'è forse qualche utilità nelpossedere altri benisenza intelligenza e sapienza?
Trarrebbe forse profitto un uomo dal possedere molte ricchezze e compieremolte azionisenza avere intelligenzao
piuttosto dal possedere poche ricchezze e compiere poche azioni conintelligenza?
Rifletti così: agendo meno non sbaglierebbe menoe sbagliando meno nonstarebbe meno malee stando meno male
non sarebbe meno infelice?» «Certo»rispose. «Si potrebbedunqueagiremeno da povero o da ricco?» «Da povero»
rispose. «Da debole o da forte?» «Da debole». «Da persona che gode dionori (33) o che non ne gode?» «Da persona
che non ne gode». «Si potrebbe agire meno da coraggioso e saggio o davile?» «Da vile».
«Allora anche da inoperoso piuttosto che da attivo?». Ne convenne.
«E da lento piuttosto che da veloce e con la vista e l'udito debolipiuttosto che acuti?». Su tutto questo ci trovammo
d'accordo. «Insomma»dissi«Cliniaè probabile che di tutte le coseche prima dicevamo essere beniin meritonon si
possa dire che siano beni in sé per naturamacome sembrala cosa stacosì: se le guida l'ignoranza sono mali maggiori
dei loro contrariquanto più sono capaci di prestare servizio alla lorocattiva guidaseinvecele guidano l'intelligenza e
la sapienza sono beni maggiorima in sé nessuna di esse vale qualcosa».«Sembraa quanto parecosì come tu affermi»
rispose. «Che cosa deriva allora per noi da quanto è stato detto? Derivaqualcos'altro se non che nessuna delle altre
realtà è buona o cattivama di queste due la sapienza è un benementrel'ignoranza è un male?». Fu d'accordo.
«Consideriamo ancora il resto»dissi. «Poiché tutti desideriamo esserefelicima è risultato che diveniamo tali per
l'uso delle cose e per l'uso correttoed era la scienza quella che fornivala correttezza e la buona fortunabisogna
quindicome sembrache ogni uomo procuri in ogni modo di essere il piùsapiente possibileo no?» «Sì»rispose. «E
se si crede che si debba ereditare proprio questo molto più che le ricchezzedal padredai tutoridagli amicidagli altri e
da quelli che dicono di essere nostri innamoratistranieri e cittadinipregando e supplicando che ci rendano partecipi
della sapienzanon è per nulla vergognosoné riprovevoleCliniaobbedire e servire per questo l'amante e ogni uomo
disposti a compiere qualsiasi servizio onestoper il desiderio di diventaresapiente; o non ti sembra così?»chiesi.
«Certomi sembra che tu dica bene»rispose. «Purché la sapienza sipossa insegnare(34) Clinia»dissi«e non
sopraggiungainvecespontaneamente agli uomini; perché questo punto non èancora stato esaminato da noi e su di
esso non siamo ancora giunti ad un accordo».
Platone Eutidemo
6
«MaSocrate»disse«a me sembra che si possa insegnare». E iorallegrandomicontinuai: «Dici proprio beneo
ottimo fra gli uominie hai fatto bene a liberarmi da una lunga riflessionesu questo argomentose cioè la sapienza si
possa insegnare o no. Oradunquepoiché a te sembra che si possa insegnaree che sia l'unica cosa a rendere felice e
fortunato l'uomopotresti dire altro se non che è necessario filosofare? Etu stesso hai in mente di farlo?» «Certamente
Socrate»rispose«per quanto è possibile».
E ioavendo udito con piacere queste paroledissi: «Questo è l'esempiooDionisodoro ed Eutidemodi come
desidero che siano i discorsi persuasiviforse esposto da uomo incompetentein modo stentato e prolisso. Machi di voi
due vuolefacendo questa stessa cosa con arteci faccia mostra di sé. Seinvece non voletepartendo dal punto in cui ho
smessomostrate il seguito al ragazzose cioè bisogna che egli acquistiogni scienza oppure se ve ne sia una sola
acquisita la qualeè necessario che sia felice e buonoe quale essa sia.Infatticome dicevo all'inizioper noi è molto
importante che questo giovinetto diventi sapiente e buono».
Dissi dunque queste paroleCritone. Prestavo grande attenzione a ciò chesarebbe avvenuto in seguito e riflettevo in
che modo avrebbero discusso l'argomento e da dove avrebbero iniziato aesortare il ragazzo a praticare la sapienza e la
virtù. Allora il più anziano di loroDionisodorocominciò a parlare perprimo e tutti guardavamo verso di luiconvinti
che ben presto avremmo ascoltato discorsi meravigliosi. E così appunto ciaccadde.
InfattiCritonequell'uomo cominciò un discorso meravigliosoche ticonviene ascoltarein quanto era
un'esortazione alla virtù.
«Dimmi»chiese«o Socrate e voi altri che affermate di desiderare chequesto giovinetto diventi sapientese
scherzate quando lo affermateoppure lo desiderate veramente e parlate sulserio».
Capii che avevano creduto che noi prima scherzassimoquando li esortavamo adiscutere col ragazzo e per questo
avevano scherzato e non avevano fatto sul serio. Dopo avere compreso ciòancor più risposi che parlavamo con
straordinaria serietà.
E Dionisodoro disse: «Bada dunqueo Socratedi non dovere poi negare ciòche ora dici». «Ho riflettuto»risposi:
«non negherò mai».
«Ma»continuò«voi affermate di volere che egli diventi sapiente?»«Certo». «Ora però»chiese«Clinia è sapiente
o no?» «Dice di non esserlo ancora non è vanitoso»risposi. «Voiinvece»chiese«volete che diventi sapiente e non sia
ignorante?».
Lo ammettemmo. «Dunque volete che diventi chi non è e che non sia più chiè ora». (35) Ascoltando queste parole
fui turbato. Ed eglicomprendendo il mio turbamentodisse: «Poiché voleteche non sia più chi è oranon volete forse
come sembrache muoia?
Sarebbero veramente di gran pregio amici e innamorati che apprezzerebberomoltissimo che il loro amato fosse
morto».
E Ctesippoudendo ciòsi adirò per il suo amato e esclamò: «O stranierodi Turise non fosse troppo villano dirlo
direi: "che possa ricadere sulla tua testa"perché ti è venutoin mente di fare calunniosamente contro di me e contro gli
altri tale affermazioneche io credo sia un'empietà faree cioè che iovorrei che costui fosse morto».
«MaCtesippo»disse Eutidemo«ti sembra forse che sia possibilementire?» (36) «Sìper Zeus»rispose«se non
sono pazzoalmeno».
«Dicendo la cosa di cui si parlao non dicendola?» «Dicendola»rispose.«Perciò se la si dicetra le cose che sono
non si dice altro che quella che si dice?» «E come si potrebbe?»chieseCtesippo. «E quella che si dice è una delle cose
che sono separate dalle altre». «Certamente». «Dunquecolui che dicequella dice ciò che è?»domandò. «Sì». «Ma chi
dice ciò che è e le cose che sono dice la veritàcosicchéseDionisodoro dice le cose che sonodice la verità e non
mente affatto contro dite».
«Sì»rispose Ctesippo«ma chi dice queste coseo Eutidemo non dicecose che sono».
Ed Eutidemo disse: «Non è vero che le cose che non sono non sono?» «Nonsono». «Non è dunque vero che le cose
che non sono non sono in nessun modo cose che sono?» «In nessun modo».
«è possibiledunquecheriguardo a queste cose che non sonosi possafare qualcosain modo che anche una
persona qualunque nossa fare quelle cose che non sono per nulla?» «Non misemra»rispose Ctesippo. «Ma i retori
quando parlano al popolonon operano nulla?» «Operanocerto»rispose.«Dunquese operanofanno anche?» «Sì».
«Il parlarealloraè operare e fare?».
Ne convenne. «Nessunoquindi»concluse«dice le cose che non sonoperché farebbe già qualcosama tu hai
riconosciuto non è possibile che qualcuno faccia ciò che non ècosicchéche secondo il tuo ragionamentonessuno dice
falsitàma se Dionisodoro parladice la verità e le cose che sono».
«Sìper Zeuso Eutidemo»rispose Ctesippo: «dice in qualche modo lecose che sonoma non come stanno».
«Come diciCtesippo?»chiese Dionisodoro. «Vi sono alcuni che dicono lecose come stanno?» «Ci sono certo»
rispose«gli uomini eccellenti sotto ogni rispetto e che dicono laverità».
«Ma»chiese«le cose buone non stanno bene e quelle cattive male?».
Ne convenne. «E ammetti che gli uomini eccellenti sotto ogni rispetto diconole cose come stanno?» «Lo ammetto».
«AlloraCtesippo»disse«gli uomini buoni dicono male delle cosecattive se le dicono come stanno». «Sìper Zeus»
rispose«è proprio cosìalmeno degli uomini cattivi; e se mi dai rettati guarderai dall'essere di questiaffinché i buoni
non dicano male di te; (37) perché sappi bene che i buoni parlano male deicattivi». «E parlano grandemente dei
grandi»continuò Eutidemo«e caldamente dei caldi?» «Esatto»risposeCtesippo: «parlano freddamente dei freddi
(38) e dicono che discutano così». «Tu insultiCtesippo»esclamòDionisodoro«tu insulti».
Platone Eutidemo
7
«Noper ZeusnoDionisodoro»replicò«perché ti voglio bene: tiammoniscocome un amicoe cerco di
persuaderti a non dire mai in modo così rozzo di fronte a me che voglio lamorte di quelli che stimo di più».
Allorapoiché mi sembrava che essi si trattassero con troppa asprezzareciprocami burlai di Ctesippo e dissi:
«Ctesippomi pare che dobbiamo accettare dagli stranieri ciò cheaffermanose vogliono farcene donoe non dissentire
con un pretesto. Seinfattisanno annientare gli uomini così da renderlibuoni e saggi da malvagi e stolti che eranosia
che abbiano scoperto da sé sia che abbiano imparato da un altro una rovina edistruzione tale da rendere di nuovo buono
chi è malvagiodopo averlo ucciso; se sanno ciò - ed è chiaro che losanno perché hanno affermato che la loro arte da
poco scoperta consiste nel rendere gli uomini buoni da malvagi - concediamodunqueloro questo: ci facciano perire il
ragazzo e lo rendano saggio e anche tutti noi altri. Ma se voi giovani avetepaurail rischio ricada su di mecome su di
un Cario; (39) perché iodal momento che sono vecchiosono pronto adespormi al pericolo e mi affido a Dionisodoro
come a Medea di Colchide (40) Mi faccia perire ese vuolemi facciacuocerealtrimenti faccia ciò che vuolepurché
mi renda buono».
E Ctesippo: «Anch'ioSocrate»disse«sono pronto a offrirmi aglistranierianche se vogliono scorticarmi ancor più
di quanto mi scorticano orapurché la mia pelle non finisca in un otrecome quella di Marsia(41) ma nella virtù.
Eppure Dionisodoro qui presente pensa che sia in collera con lui; e invecenon sono in collerama contraddico ciò che
mi sembra egli dica in modo non conveniente dinanzi a me. Ma tu»aggiunse«nobile Dionisodoronon chiamare
"insultare" il contraddire: l'insultare è altra cosa».
E Dionisodoro chiese: «O Ctesippoparli del contraddire come seesistesse?» «Certamente»rispose«proprio così;
oppure tuo Dionisodoronon credi che esista il contraddire?» (42)«Sicuramente tu»ribatté«non potresti mai
dimostrare di avere udito qualcuno contraddire un altro».
«Dici la verità?»replicò. «Ma ora ti dimostro di stare ascoltandoCtesippo che contraddice Dionisodoro».
«Potrestiforseanche rendere ragione di questo?» «Certamente»rispose.
«Ma»domandò«esistono delle ragioni per ciascuna delle cose chesono?» «Sicuramente». «In quanto ciascuna
cosa è o in quanto non è?» «In quanto è». «Infatti se ricordi»continuò«Ctesippoanche poco fa abbiamo dimostrato
che nessuno parla di una cosa in quanto non è; perché è risultato chenessuno dice ciò che non è».
«E con questo?»chiese Ctesippo. «Ci contraddiciamo meno io e tu?» «Cicontraddiremmo forse»ribatté egli«se
entrambi parlassimo della stessa cosao così diremmo certamente le stessecose?».
Lo ammise. «Maquando nessuno di noi due»domandò«parlasse di unacosaallora ci contraddiremmo? O così
nessuno di noi due si ricorderebbe affatto di essa?». Anche in questo fud'accordo.
«Ma quando io parlo di una cosamentre tu parli di un'altraallora cicontraddiciamo? Oppure io parlo di una cosa
mentre tu non ne parli affatto? Chi non parla come porebbe contraddire chiparla? ».(43) Ctesippo tacquementre io
meravigliato del discorsochiesi: «Come diciDionisodoro? Pur avendo uditoquesto discorso da molti e spessome ne
meraviglio sempre - e infatti i seguaci di Protagora (44) se ne servivanomolto e anche quelli ancora più antichi; (45)
eppure a me sembra sempre che sia meraviglioso e abbatta gli altri e anche sestesso -; e credo che verrò a sapere da te
nel modo migliore la verità di esso. Non è vero che dire il falso nonesiste?
Questoinfattisignifica il ragionamento: che chi parla dice il vero o nonparla?».
Ne convenne.
«Forsedunquenon è possibile dire il falsoma è possibile avere falseopinioni?» «Neppure avere false opinioni»
affermò.
«Allora»dissi«non esiste neppure la falsa opinione».
«No»rispose.
«Allora nemmeno l'ignoranza né gli uomini ignoranti; o l'ignoranzaseesistessenon sarebbe l'ingannarsi sulle
cose?» «Certamente»disse.
«Ma questo non è possibile»continuai.
«No»rispose.
«Dionisodoroparli tanto per parlareper dire un'assurditàoppureperché ti pare veramente che nessun uomo sia
ignorante?» «Allora tu confutami»ribatté.
«è forse possibilesecondo il tuo ragionamentoconfutare se nessuno siinganna?» «Non è possibile»rispose
Eutidemo.
«Allora»chiesi«poco fa Dionisodoro non mi esortava a confutarlo?»«Come potrebbe uno esortare a ciò che non
è. Ma tu inviti?» «Eutidemo»dissi«non comprendo bene queste vostresapienti trovateanche quelle ben impostate
ma le capisco solo approssimativamente.
Ti faròdunqueuna domanda forse troppo grossolanama perdonami.
Vedi: se non è possibile né ingannarsiné avere false opinioninéessere ignorantenon è forse neppure impossibile
sbagliarequando si fa qualcosa? Infatti non è possibile che chi fa sbagliin ciò che fa: non dite così?» «Certamente»
rispose.
«Oraquesta è la domanda grossolana»ripresi. «Se non sbagliamo néagendoné parlandoné pensandovoiper
Zeusse le cose stanno cosìche cosa siete venuti a insegnarci? O nonaffermavate poco fa di potere trasmettere meglio
di ogni altro la virtù a chi vuole apprenderla?».
Dionisodoro prese la parola e disse: «Socratesei così rimbambito (46) cheti ricordi adesso ciò che abbiamo detto
prima ese ho detto qualcosa l'anno scorsosei in grado di ricordarteneorama con i discorsi fatti in questo momento
non sei in grado di cavartela?» «Sono molto difficili»replicai«a buondirittoperché sono fatti da uomini sapienti:
Platone Eutidemo
8
perciò è difficilissimo cavarsela anche con quest'ultimo discorso che fai.Infatti che cosa mai vuoi direDionisodoro
affermando che non so come cavarmela? O evidentemente vuoi dire che non soconfutarlo? Perciò spiegami che
cos'altro significa per te l'espressione "non so come cavarmela con ituoi discorsi"».
«Ma ciò che tu dici»ribatté«perciò rispondi».
«Prima che tu rispondao Dionisodoro. »domandai io.
«Non rispondi?»incalzò.
«è forse giusto?» «Certamente giusto»rispose.
«Per quale ragione»chiesi«o evidentemente perché tu ora sei venuto danoi sapientissimo nei discorsi e sai quando
bisogna rispondere e quando no? E adesso non rispondi nullaperché sai chenon bisogna rispondere?» «Tu ciarli»
disse«senza pensare a rispondere. Mamio carodammi retta e rispondipoiché ammetti che io sono sapiente».
«Bisognadunqueobbedire»continuai«ed è necessarioa quanto pareperché lo comandi tu. Ma interroga».
«Gli esseri pensanti hanno forse senso perché hanno un'anima o hanno sensoanche quelli inanimati?» (47) «Quelli
che hanno un'anima».
«Conosci»chiese«qualche espressione che abbia un'anima»?
«Per Zeusio no».
«Perché allora poco fa mi hai domandato che cosa significasse per mel'espressione?» «Per quale altro motivo»
risposi«se non perché ho sbagliato per la mia stupidità? O non hosbagliatoma ho parlato correttamenteaffermando
che le espressioni hanno senso? Dici che io abbia sbagliato o no? Perché senon ho sbagliatoneppure tu mi potrai
confutareanche se sei sapientee non sai come cavartela con il discorso;se invece ho sbagliato neppure così parli
correttamentesostenendo che non è possibile sbagliare. E dico questo nonin riferimento a ciò che affermavi l'anno
scorso. Masembra»continuai«o Dionisodoro ed Eutidemoche questoragionamento rimanga fermo allo stesso punto
e che ancoracome in passatodopo avere abbattuto il restocada e il modoperché non gli accadesse questo non è
ancora stato trovato neppure dalla vostra artesebbene essa sia cosìmeravigliosa nel rigore dei ragionamenti».
E Ctesippo esclamò: «Dite cose meraviglioseo uomini di Turi o di Chio odi dove e come vi piaccia essere
chiamati(48) perché non vi importa affatto di delirare».
E iotemendo ne derivasse un insultocalmai di nuovo Ctesippo e affermai «Ctesippodico anche a te le stesse
parole che dicevo poco fa a Clinia: non sai che la sapienza degli stranieriè meravigliosa.
Tuttavia essi non vogliono mostrarcela seriamente ma imitano Proteo(49) ilsofista egizianoincantandoci. Noi
allora imitiamo Menelao (50) e non lasciamo andare questi due uomini finchénon ci abbiano mostrato ciò di cui si
occupano seriamente.
Credoinfattiche ci mostreranno qualcosa di bellissimoquandocominceranno a parlare sul serio. Ma preghiamoli
esortiamoli e supplichiamoli di mostrarcelo. Ho dunque deciso di mostrare dinuovo io come supplicarli di rivelarlo.
Cercherò di esporre loro il seguitocome possopartendo dal punto in cuiprima avevo interrotto il discorsoper vedere
se in qualche modo riesco a stimolarli e seprovando pietà e compassioneper me che mi sforzo e parlo seriamente
anch'essi facciano sul serio».
«E tuClinia»dissi«ricordami da che punto allora avevamo interrottoil discorso. All'incirca quicredo. Alla fine
avevamo ammesso che bisogna filosofare non è vero?» «Sì»rispose egli.«E la filosofia è acquisto di scienza; non è
così?»domandai. «Sì»disse.
«Alloraacquistando quale scienzafacciamo un buon acquisto? Non è forsesemplice rispondere: quella che ci sarà
utile?» «Certo»rispose. «Dunque ricaveremmo qualche utilitàsesapessimo riconoscereandando in giroin quale
punto della terra sia stata sotterrata la maggior quantità d'oro?»«Forse»disse. «Ma prima»ribattei«abbiamo
dimostrato che non avremmo nessun vantaggioneppure se tutto diventasse oroper noisenza difficoltà e senza scavare
la terra. Cosicchéneppure se sapessimo rendere d'oro le pietretalescienza non varrebbe nulla. è risultatoinfattiche
se non sapremo anche servirci dell'oronessuna sarà la sua utilità pernoi. O non ricordi?»chiesi. «Certoricordo»
rispose.
«Ea quanto parenon deriva nessuna utilità neppure dalle altre scienze;né dalla crematistica(51) né dalla scienza
medicané da nessun'altra che sappia produrre qualcosama non sappiaservirsi di ciò che ha prodotto: non e così?».
Assentì. «E neppure se esistesse una scienza tale da rendere immortalimanon sapesse servirsi dell'immortalità
neppure da questa sembra ricaveremmo alcuna utilità se bisogna giudicarequalcosa da quanto si è ammesso prima».
Fummo d'accordo su tutti questi punti. «Abbiamo bisognoO bel giovinetto»dissi«di una scienza tale che in essa
coincidano il produrre e il sapere servirsi di ciò che si produce».
«Già»rispose. «Alloraparesiamo ben lungi dal dover esserecostruttori di lire e possessori di una tale scienza
perché in questo caso l'arte che produce e l'arte che utilizza sononettamente separatepur riferendosi allo stesso
oggetto. L'arte di fabbricare le lire e l'arte di suonare la cetra sono moltodiverse fra loro: non è così?». Assentì. «Ed è
chiaro che non ci serve neppure l'arte di costruire flauti perché anchequesta è simile alla precedente». Ne convenne.
«Maper gli dèi»continuai«se imparassimo l'arte di comporrediscorsisarebbe forse questa che dovremmo possedere
per essere felici?» «Non credo»ribatté Clinia di rimando.
«Come puoi provarlo?»chiesi io.
«Vedo»rispose«alcuni scrittori di discorsi (52) che non sanno servirsidei discorsi composti da loro stessicome i
costruttori di lire non sanno usare le lirema anche in questo caso altriincapaci di scrivere personalmente discorsisono
capaci di servirsi di quelli che i primi hanno composto. è chiarodunqueche anche riguardo ai discorsi l'arte di produrli
e quella di servirsene sono diverse».
Platone Eutidemo
9
«Mi sembra»dissi«che tu dia una prova sufficiente del fatto che l'artedegli scrittori di discorsi non sia quella che
si deve possedere per essere felici. Eppure credevo che in questo caso forsesarebbe apparsa la scienza che da molto
tempo cerchiamo.
InfattiCliniaquesti uominigli scrittori di discorsiquando mi trovocon loromi sembrano sapientissimi e la loro
mi pare un'arte prodigiosa e sublime. E non c'è da meravigliarsiperchéessa è una parte dell'arte degli incantatori ed è
un po' inferiore a quella.
L'arte degli incantatoriinfatticonsiste nell'incantare viperetarantolescorpioni e altre fiere e malattiel'altra
invececonsiste nell'incantare e addolcire giudicimembri dell'assembleapopolare e altre folle. (53) Oppure a te»
domandai«sembra che sia in qualche altro modo?» «Noma mi pare che siacome dici tu»rispose.
«Allora»chiesi«dove potremmo ancora rivolgerci? A quale arte?» «Nonsono in grado di rispondere»affermò.
«Ma credo di averla trovata»replicai.
«Qual è?»domandò Clinia.
«Mi sembra che l'arte strategica sia quella che più di ogni altra potrebberendere felice chi la possiede».
«Non mi pare».
«Come?»chiesi io.
«Questa è un'arte che va a caccia di uomini».
«Perché mai?»domandai io.
«Nessun'arte di caccia va oltre l'inseguire e catturare la preda.
Dopo che hanno catturato ciò che caccianonon sono capaci di servirsenemai cacciatori e i pescatori lo
consegnano ai cuochimentre i geometrigli astronomi e i ragionieri -infatti sono anche questi cacciatoriperché
ciascuno di essi non produce le figurema scopre quelle che esistono -poichédunqueessi non sono capaci di servirsi
di quellema solo di cacciarleaffidano ai dialettici (54) il compito divalersi delle loro scopertealmeno quelli tra loro
che non sono completamente stolti».
«Bene»dissi«o bellissimo e sapientissimo Clinia: è così?» «Certo.Anche gli strateghi»affermò«fanno allo
stesso modo. Dopo che hanno preso una città o un accampamentolo consegnanoai politici - essi infatti non sanno
servirsi di ciò che hanno preso - comecredoi cacciatori di quaglieconsegnano le prede agli allevatori.(55) Se
dunque»continuò egli«abbiamo bisogno di quell'arteche saprà ancheservirsi di ciò che ha acquistatoavendolo
prodotto o cacciato essa stessae tale arte ci renderà felicialloradobbiamo cercarne un'altra al posto della strategia».
CRITONE: Che cosa dicio Socratequel ragazzo pronunciò tali parole?
SOCRATE: Non credio Critone?
CRITONE: Noper Zeuscertamente no. Io pensoinfattiche se avesse dettoqueste paroleegli non avrebbe
bisogno né di Eutidemoné dì nessun altro uomo per la sua educazione.
SOCRATE: Ma alloraper Zeusche sia stato Ctesippo a parlare cosìe ionon lo ricordo?
CRITONE: Quale Ctesippo?
SOCRATE: So bene che non furono né Eutidemoné Dionisodoro a dire ciò.Mao divino Critoneche lo abbia
detto uno degli esseri superiori lì presente? So beneinfattidi averloudito.
CRITONE: Sìper Zeuso Socrate. Mi sembra proprio uno degli esserisuperiori (56) e molto. Ma poi avete parlato
ancora di qualche altra arte? E avete trovato o no quella che miravate acercare?
SOCRATE: Doveo caropotevamo trovarla? Eravamo invece molto ridicoli: comei bambini che inseguono le
allodolecredevamo sempre di riuscire subito a afferrare ognuna dellescienzema esse ci sfuggivano sempre. Perché
raccontarti a lungo? Giunti all'arte di regnare ed esaminandola a fondopervedere se fosse quella a offrire e a produrre
la felicitàcaduti allora come in un labirintomentre credevamo di essereormai alla finerisultò che eravamo ritornati
come all'inizio della ricerca e avevamo bisogno della stessa cosa che cioccorreva quando avevamo incominciato a
cercare.
CRITONE: Comedunquevi accadde questoo Socrate?
SOCRATE: Te lo dirò. Ci sembròinfattiche l'arte politica e quella diregnare fossero la stessa arte.
CRITONE: Perché mai?
SOCRATE: Ci parve che l'arte strategica e le altre arti affidassero ilcompito di guidare i prodotti dei quali esse sono
artefici a quest'artecome alla sola che sappia servirsene. Ci sembròdunqueche fosse chiaramente quella che
cercavamo e la causa del retto agire nella cittàe che proprio secondo ilgiambo di Eschilo(57) sola sedesse alla poppa
della cittàgovernando tutto ecomandando su tuttorendesse tutto utile.
CRITONE: E vi sembrava beneo Socrate?
SOCRATE: Giudicherai tuo Critonese vuoi ascoltare anche ciò che ciaccadde in seguito. Infatti indagavamo di
nuovo press'a poco così: «Ebbene l'arte di regnare che comanda su tutto ciproduce qualche risultato o nessuno?
Certamente lo produce»dicevamo fra di noi. Non diresti anche tu questoCritone?
CRITONE: Sì.
SOCRATE: Quale diresti che sia il suo risultato? Comead esempiose tichiedessi quale risultato offre l'arte
medicache dirige tutto ciò che dirigenon risponderesti la salute?
CRITONE: Sì.
SOCRATE: Che cosa produce la vostra arte(58) l'agricolturache governatutto ciò che governa? Non risponderesti
che ci offre il nutrimento che si ricava dalla terra?
CRITONE: Sì.
Platone Eutidemo
10
SOCRATE: Che cosa produce l'arte di regnareche comanda su tutto ciò su cuicomanda? Forse non sei
assolutamente in grado di rispondere.
CRITONE: Noper Zeuso Socrate.
SOCRATE: Neppure noio Critone. Ma almeno sai chese è quella che noicerchiamodeve essere utile.
CRITONE: Certamente.
SOCRATE: Allora bisogna che essa ci trasmetta qualche bene.
CRITONE: è necessarioo Socrate.
SOCRATE: Ma io e Clinia avevamo reciprocamente ammesso che un bene non ènient'altro che una determinata
scienza.
CRITONE: Sìdicevi così.
SOCRATE: Allora gli altri risultati che si potrebbero attribuire allapolitica - e questi potrebbero essere molti come
ad esempiorendere ricchiliberi e concordi i cittadini - tutti questi cisembrarono né cattivi né buonima ci sarebbe
stato bisogno che la politica rendesse sapienti e comunicasse una scienzasequesta doveva essere quella che giovava e
rendeva felici.
CRITONE: è così. Alloraalmenoquesto era stato ammesso da voistando acome tu hai riferito i vostri discorsi.
SOCRATE: L'arte di regnare rende forse sapienti e buoni gli uomini?
CRITONE: Che cosa lo impedisceo Socrate?
SOCRATE: Ma rende buoni tutti e in tutto? Ed è questa che trasmette ogniscienzaquella del calzolaioquella del
falegname e tutte le altre?
CRITONE: Non credoo Socrate.
SOCRATE: Ma allora quale scienza trasmette? Che uso ne faremo?
Bisognainfattiche essa non sia artefice di nessun risultato né cattivoné buonoe che non trasmetta nessun'altra
scienza se non se stessa. Diciamodunquequale sia mai questa scienza equale uso ne faremo. Vuoi che affermiamoo
Critoneche sia quella per mezzo della quale renderemo buoni gli altri?
CRITONE: Certamente.
SOCRATE: Ed essi in che cosa saranno buoni per noi e in che cosa sarannoutili? O dobbiamo ancora dire che
renderanno altri buoni e quegli altri a loro volta buoni altri? Ma in checosa mai siano buoni non ci appare affatto
poiché abbiamo disprezzato i risultati attribuiti alla politicamentre sirealizza proprio il detto «Corintofiglio di Zeus»
(59) ecome dicevosiamo lontani allo stesso modo o ancora di più dalsapere quale sia mai quella scienza che ci
renderà felici.
CRITONE: Sìper Zeuso Socrategiungeste ad una grande aporiaa quantopare.
SOCRATE: Io stessoCritonedopo esser caduto in quest'aporiausai ognimezzo per pregare i due straniericome
se invocassi i Dioscuri(60) di salvarcime e il ragazzodalla terzaondata (61) del ragionamentodi essere seri in ogni
modo e di mostrarci seriamente quale sia mai la scienzaraggiunta la qualepotremmo trascorrere bene il resto della
vita.
CRITONE: Ma Eutidemo consentì a mostrarvi qualcosa?
SOCRATE: Come no? E incominciò il discorsoo compagnocon molto orgogliocosì.
«O Socrate»chiese«ti devo insegnare questa scienzasulla quale damolto tempo siete in difficoltào devo
dimostrarti che la possiedi?» «O beato»domandai«questo è possibilesecondo te?» «Certamente»rispose.
«Dimostrami alloraper Zeus»ripresi«che la posseggo; infatti è moltopiù facile che impararla per un uomo della
mia età».
«Orsùrispondimi»disse: «c'è qualcosa che sai?» «Certo»affermai«e molte cosema di poca importanza».
«Basta»asserì. «Credi forse che sia possibile che qualcuna delle coseche sono non sia proprio ciò che è?» «Ma noper
Zeus». «Tu dunque»chiese«sai qualcosa?» «Sì». «Perciò se saisei sapiente?» (62) «Certoalmeno in questo punto».
«Non importa; ma non è necessario che tuse sei sapientesappia tutto?»«Noper Zeus»risposi«perché non so molte
altre cose». «Allora se non sai qualcosa non sei sapiente».
«Almeno in quelloamico»ribattei. «Sei dunque un po' meno ignorante?»domandò. «Ma poco fa hai detto di
essere sapiente. E così ti trovi ad essere e poi di nuovo a non esserequello che sei riguardo alle stesse cose e nello stesso
tempo».
«BeneEutidemo»risposi: «come si dicefai risuonare belle parole. Comesodunquequella scienza che
cercavamo? Poiché è impossibile che la stessa cosa sia e non siase so unacosa le so tutte - infatti non potrei essere
sapiente e ignorante nello stesso tempo - mapoiché so tuttoho anchequella scienza. Dici forse così ed è questa la tua
gran sapienza?» «Tu stesso ti confutio Socrate»disse.
«MaEutidemoa te non è accaduta la stessa cosa?»ribattei. «Ioqualsiasi cosa mi succedesse insieme a te e a
Dionisodoromio caro amico(63) non mi irriterei affatto. Dimminon èvero che voi due sapete alcune delle cose che
sonoma non ne sapete altre?» «Niente affattoSocrate»risposeDionisodoro.
«Come dite?»chiesi io. «Ma allora non sapete nulla?» «Certamentesappiamo»rispose egli.
«Allora sapete tutto»dissi«poiché sapete anche una cosa qualsiasi?»«Tutto»ribatté«e anche tu se sai anche una
sola cosale sai tutte».
«O Zeus»esclamai«che cosa meravigliosa affermi e che grande bene èche sia stata rivelata! Forse anche tutti gli
altri uomini sanno tutto oppure nulla?» «Certo è impossibile»rispose«che sappiano alcune cose e non ne sappiano
altre e siano nel tempo stesso sapienti ed ignoranti».
Platone Eutidemo
11
«Ma perché?» chiesi io.
«Tutti»disse«sanno tutto se sanno anche una sola cosa».
«O per gli dèiDionisodoro!»esclamai. «Mi è chiaro ormai che parlatesul serioma a fatica vi ho indotti ad essere
seri.
Voi due sapete realmente tutto? Per esempio l'arte del falegname e quella delcalzolaio?» «Certamente»rispose.
«Sieteforseanche capaci di rattoppare scarpe?» «Sìper Zeusanchedi risuolarle»affermò.
«E sapete forse anche cose di questo tipo: quante sono le stelle e quantisono i granelli di sabbia?» «Certo»rispose.
«Poicredi che non lo avremmo ammesso?» Ctesippo intervenne ed esclamò:«Per ZeusDionisodorodatemi una prova
di questodalla quale saprò che dite la verità».
«Quale prova ti darò?»chiese.
«Sai quanti denti (64) ha Eutidemo e Eutidemo quanti ne hai tu?» «Non tibasta avere sentito che sappiamo tutto?»
domandò.
«Assolutamente no»rispose«ma diteci ancora solo questo e dimostrateciche dite la verità. E se dite quanti denti
ha ciascuno di voie se risulta che lo sapetedopo che noi li abbiamocontativi crederemo subito anche nel resto».
Ritenendo di essere schernitinon vollero risponderema interrogati daCtesippo su ogni singola cosaammisero dì
saperle tutte. Infatti non vi fu nulla su cuiinfineCtesippo moltoapertamente non domandasse se lo sapesseroanche le
cose più vergognose.
Ed essi molto coraggiosamente affrontavano le domandeammettendo di saperecome i cinghiali che si slanciano
contro il colpocosicché anch'ioo Critonealla fine fui costretto dallamia incredulità a chiedere se Dionisodoro
sapesse anche danzare.
Ed egli: «Certamente»rispose.
«Senza dubbio»dissi«alla tua età non saprai anche fare il saltomortale sulle spade e girare sulla ruota: non sei così
progredito nella sapienza».
«Non c'è nulla che non sappia»ribatté.
«Forse»chiesi«sapete tutto solo ora o da sempre?» «Da sempre»replicò.
«Anche quando eravate bambini e appena nati sapevate tutto?».
Entrambi insieme assentirono.
E a noi la cosa sembrava incredibile. Ma Eutidemo domandò: «Non credioSocrate?» «Nosalvo che è probabile
che siate sapienti»risposi.
«Ma»disse«se vuoi rispondermiio ti dimostrerò che anche tu ammettiqueste cose meravigliose».
«Ma certo»replicai. «Mi fa molto piacere essere confutato su questo. Seinfattimi è davvero sfuggito dì essere
sapientema tu mi dimostrerai che so tutto e da semprequale scoperta piùfelice di questa potrei fare in tutta la mia
vita?» «Rispondidunque»disse.
«Domandaconvinto che io ti risponda».
«DunqueSocratesei forse sapiente in qualcosa o no?» «Sì».
«E sai con ciò per cui sei sapiente o con qualcos'altro?» «Con ciò percui sono sapiente. Credoinfattiche tu parli
dell'anima(65) o non parli di questo?» «Non ti vergogniSocrate»disse: «tu che sei interrogatointerroghi a tua
volta?» «Bene»replicai«ma come faccio? Farò come tu ordini. Quandonon so che cosa chieditu mi ordini tuttavia di
risponderesenza interrogare di nuovo?» «Infatti intendi in qualche modociò che dico?»domandò.
«Sì»affermai.
«Rispondi dunque a ciò che intendi».
«Ma»ribattei«se tu domandi intendendo in un modoma io comprendo inun altro e poi rispondo a questoti basta
se non rispondo nulla a proposito?» «A me sìma non a tecome credo»disse egli.
«Noper Zeusnon risponderò prima di avere capito»replicai.
«Non risponderai»ribatté«a ciò che man mano comprendiperchécontinui a dire sciocchezze e sei più antiquato
del dovuto».
E io compresi che era in collera con me che distinguevo ciò che dicevaperché voleva darmi la caccia
circondandomi con le parole. Mi ricordai allora di Connoche si adiraanch'egli con meogni volta che non gli cedo e
poi si prende meno cura di mecome se fossi ignorante. Ma poiché avevodeciso di frequentare anche costuicredetti di
dovere cedereper evitare cheritenendomi uno scolaro inettonon miaccettasse.
Dissi dunque: «Ma se ti sembra bene fare cosìEutidemobisogna farloperché tu certamente sai discutere meglio di
meche ho la tecnica di un incompetente. Domandadunquedi nuovo daprincipio».
«Rispondi nuovamenteallora»riprese: «sai forse con qualcosa ciò chesai o no?» «Sì»affermai«con l'anima».
«Costui»esclamò«risponde di nuovo oltre il richiesto alle domande:non chiedo con che cosa saima se sai con
qualcosa».
«Ho risposto più del dovuto»dissi«per ignoranza. Perdonami: ora tirisponderò semplicemente che so con
qualcosa ciò che so».
«Sempre (66) con la stessa cosa»chiese«o talvolta con questatalvoltacon un'altra?» «Quando soso sempre con
questa»dissi.
«Non smetterai di fare di nuovo aggiunte?»esclamo.
«Ma badiamo che in qualche modo questo "sempre" non ci tragga ininganno».
«Certo non noi»disse«mase maite. Ma rispondi: sai sempre conquesta cosa?». «Sempre»ribattei«dal
Platone Eutidemo
12
momento che bisogna togliere il "quando"». «Dunque sai sempre conquesta cosa. Mapoiché sai sempresai forse
alcune cose con questa con cui sai e altre con un'altra o sai tutte conquesta?» (67) «So tutto con questaalmeno ciò che
so»risposi.
«Ecco qui»esclamò«arriva la stessa aggiunta».
«Tolgo "almeno ciò che so"»dissi io.
«Non togliere neppure una parola»replicò: «non ho affatto bisogno dite.
Rispondimi: potresti sapere tutte le cose se non sapessi tutto?» «Sarebbeun prodigio»risposi.
Ed egli disse: «Aggiungi ora ciò che vuoi; infatti ammetti di saperetutto».
«Credo»ribattei«dal momento che le parole "ciò che so" nonhanno alcuna importanzaso tutto».
«Dunque hai anche ammesso di sapere sempre con quella cosa con cui saisiaquando saisia come vuoi: infatti hai
ammesso di sapere sempre e tutto nello stesso tempo. Perciò è chiaro cheanche quando eri bambino sapeviquando
nascestiquando fosti generatoprima di nascereprima che fossero generatiil cielo e la terrasapevi tuttose sai da
sempre. Sìper Zeus»disse«anche tu saprai sempre e tuttose iovoglio».
«Ma lo volessi»esclamai«o molto stimato Eutidemo(68) se dicirealmente la verità! Però non credo affatto che tu
sia capacese non lo vuole insieme a te tuo fratello Dionisodoro quipresente.
Così forse saresti capace». Continuai: «Ditemi - sul resto non so comeobiettare a voiuomini così prodigiosi per
sapienzache io non so tuttodal momento che voi lo affermate -: come possodire di sapere che gli uomini buonisono
ingiustiEutidemo?
Orsùdimmiso questo o non lo so?» «Certamente lo sai»rispose.
«Che cosa?»chiesi io.
«Che i buoni non sono ingiusti».
«Certamente»replicai«da molto tempo. Ma non domando questo; bensìdove ho appreso che i buoni sono
ingiusti».
«In nessun luogo»ribatté Dionisodoro.
«Allora non so questo»conclusi io.
«Rovini il ragionamento»disse Eutidemo a Dionisodoro«e sembrerà checostui non sappia e che sia sapiente e
ignorante nello stesso tempo».
E Dionisodoro arrossì.
«Ma tu»continuai«come diciEutidemo? Non ti sembra che tuo fratelloche sa tutto parli correttamente?» «Sono
fratello di Eutidemo?»chiese Dionisodoroprendendo subito la parola.
E io risposi: «Lascia andarecaro miofinché Eutidemo non mi abbiainsegnato che so che gli uomini buoni sono
ingiusti e non rifiutarmi tale insegnamento».
«Tu sfuggiSocrate»disse Dionisodoro«e non vuoi rispondere».
«Naturalmente»ribattei. «Infatti sono inferiore anche a uno solo di voicosicché sono molto lungi dal non sfuggire
tutti e due. Sono molto più debole di Eracle(69) il quale non era in gradodi combattere contro l'idra che era una sofista
e chese qualcuno le tagliava un capo del ragionamentoper la sua sapienzane faceva rispuntare molti al posto di unoe
contro un granchioun altro sofistagiunto dal mareapprodato da poco(70) mi sembra. Eglipoiché il granchio da
allora lo tormentava così a sinistracon parole e morsichiamò in aiutoil nipote Iolao che lo aiutò adeguatamente.
Ma il mio Iolaose venissepeggiorerebbe la situazione».
«Rispondidunque»riprese Dionisodoro«poiché hai cantato questo inno.Forse Iolao era nipote di Eracle più che
tuo?» «è meglio per meo Dionisodororisponderti»dissi io. «Infatticertamente non smetterai di interrogarmisono
quasi sicuro di questoperché sei invidioso e per impedire che Eutidemo miinsegni quella grande sapienza». «Rispondi
dunque»replicò. «Allora rispondo»dissi«che Iolao era nipote diEraclemacome mi sembraniente affatto mio.
Infatti suo padre non era Patrocle(71) mio fratelloma uno dal nomesimileIficle(72) fratello di Eracle». «Ma
Patrocle»chiese«è tuo fratello?» «Certo»affermai«nato dallastessa madre almenoma non dallo stesso padre».
«Allora è e non è tuo fratello». «Non nato dallo stesso padrealmenomio caro»risposi«perché suo padre era
Cheredemoil mioinveceSofronisco». «Ma padre era tanto Sofroniscoquanto Cheredemo?»domandò. «Certo»
ribattei«l'uno miol'altro suo».
«Dunque»disse«Cheredemo era diverso dal padre».
«Dal mioalmeno»replicai. «Eradunquepadrepur essendo diverso dalpadre? O tu sei lo stesso di questa
pietra?» «Temo»risposi«di sembrare lo stesso per causa tua; tuttaviaa me non sembra».
«Allora sei diverso da questa pietra?»chiese. «Diversocertamente».
«Non èdunquevero che essendo diverso dalla pietra non sei pietra? Edessendo diverso dall'oro non sei oro?» «è
così». «Anche Cheredemoallora»disse«essendo diverso dal padre nonè padre».(73) «Sembra»risposi«che non sia
padre».
«SeinfattiCheredemo è padre»disse Eutidemo prendendo la parola«asua volta Sofroniscoessendo diverso dal
padrenon è padrecosicché tuo Socratesei senza padre».
E Ctesippo prendendo la parola chiese: «E a vostro padre non è accadutaquesta stessa cosa? è diverso da mio
padre?» «Niente affatto»rìbatté Eutidemo. «Ma»domandò«è lostesso?» «Lo stessocertamente». «Non potrei
acconsentire. Ma forseEutidemoè solo padre mio o anche degli altriuomini?» «Anche degli altri»rispose. «O credi
che lo stesso uomoessendo padrenon sia padre?» «Lo credevocertamente»replicò Ctesippo. «Ma credevi»chiese
«che una cosaessendo oronon fosse oro o essendo uomonon fosse uomo?»«Bada che non si realizziEutidemoil
Platone Eutidemo
13
proverbio "non cuci lino con lino"»(74) esclamò Ctesippo«perché dici una cosa singolarese tuo padre è padre di
tutti».
«Ma è così»affermò. «Degli uomini»domandò Ctesippo«o anche deicavalli e di tutti gli altri animali?» «Di
tutti»rispose.
«E anche la madre è madre di tutti?» «Anche la madre».
«Tua madredunqueè madre anche dei ricci di mare?»proseguì. «Anchela tua»ribatté. «E tuallorasei fratello
dei ghiozzidei cagnolini e dei porcellini». «Anche tu»rispose.«Allora tuo padre è un cinghiale e un cane». «Anche il
tuo»replicò.
«Mase mi rispondiCtesippolo ammetterai subito»affermò Dionisodoro.Dimmihai un cane?» «Sìanche molto
cattivo»ribatté Ctesippo. «Ha dei cagnolini?» «Sìcertamente altricani somiglianti a lui»replicò. «Il cane èdunque
loro padre?» «Io l'ho visto accoppiarsi con la cagna»disse. «Ma non ètuo il cane?» «Certo»rispose. «Alloraessendo
tuo(75) è padrecosicché il cane diventa tuo padre e tu diventi fratellodei cagnolini».
E di nuovoDionisodoroprendendo subito la parolaaffinché Ctesippo nonparlasse prima disse: «E rispondi ancora
a una piccola domanda: percuoti questo cane?». E Ctesipporidendorispose:«Sìper gli dèiperché non posso
picchiare te». «Dunque tu picchi tuo padre»concluse.
«Picchiereituttaviacon molta più ragione vostro padre»ribattéperché gli è venuto in mente di generare figli così
sapienti.
Ma certocredoEutidemoil padre vostro e dei cagnolini ha tratto grandevantaggio da questa vostra sapienza».
«Ma non ha affatto bisogno di grandi vantaggiCtesipponé quello nétu».
«Neppure tuEutidemo?»chiese.
«E neppure nessun altro degli uomini. DimmiinfattiCtesippose ritieniche sia un bene per chi è malato bere un
farmacoquando ne ha bisognoo se ti sembra che non sia un bene. O quandova in guerraandarci con le armi piuttosto
che senz'armi».
«Mi sembra»rispose. «Tuttavia credo che dirai qualcosa di bello».
«Lo saprai benissimo»continuò«ma rispondi. Poiché hai ammesso che èun bene per un uomo bere un farmaco
quando ne ha bisognonon deve forse bere questo bene il più possibileenon starà bene allora se qualcunodopo averlo
tritatogli mescola un carro di elleboro?».(76) E Ctesippo replicò:«CertoEutidemose chi beve è grande come la
statua di Delfi».(77) «Perciòanche in guerra»domandò«poiché èbene avere armibisogna avere il maggior numero
possibile di lance e scudidal momento che è bene?» «Certo»affermòCtesippo; «ma non credio Eutidemoche basti
un solo scudo e una sola lancia?» «Sì».
«Tu avresti armato così anche Gerione e Briareo?»(78) chiese.
«Credevo che tu fossi più abiledal momento che sei maestro d'armi e anchequesto tuo compagno lo è».
Ed Eutidemo tacque. Dionisodoroinvecein riferimento alle risposteprecedenti domandò a Ctesippo: «Dunqueti
sembra sia un bene possedere anche dell'oro?» «Certoe molto»risposeCtesippo.
«Non credi sia necessario avere beni sempre e ovunque?» « Proprio così»disse.
«Dunque ammetti che anche l'oro sia un bene?» «L'ho ammesso»ribatté.
«Allora bisogna averne sempreovunque e quanto più possibile in se stessi?(79) E uno sarebbe felicissimo se
avesse tre talenti (80) d'oro nello stomacoun talento nel cranio e unostatere (81) d'oro in ciascun occhio?» «Dicono
Eutidemo»proseguì Ctesippo«che i più felici e i migliori tra gliSciti siano quelli che hanno molto oro nei propri
crani(82) secondo il discorso per cui poco fa dicevi padre il cane e ciòche è ancora più singolare è che bevono anche
dai loro crani indorati e li osservano all'internotenendo fra le mani laloro sommità».
«Ma gli Sciti e gli altri uomini vedono le cose che si possono vedere oquelle che non si possono?»(83) chiese
Eutidemo.
«Quelle che si possono vederecerto».
«Perciò anche tu?»domandò.
«Anch'io».
«Vedi i nostri vestiti?» «Sì».
«Questiallorapossono vedere».
«Straordinariamente»rispose Ctesippo. «E allora?»disse.
«Nulla. Ma tu forse non credi che essi vedano: sei così ingenuo!
Mi sembraEutidemoche tu dorma ad occhi aperti e chese si può non direnulla parlandotu faccia proprio
questo».
«Non è forse possibile»chiese Dionisodoro«parlare tacendo?» «Innessun modo»replicò Ctesippo. «E nemmeno
tacere parlando?» «Ancora meno»ribatté. «Perciò quando parli dipietredi legni e di ferrinon parli di cose che
tacciono?» (84) «Certo no»rispose«se passo nelle officine dei fabbrima si dice che i ferri risuonino e rimbombino
molto fortementese qualcuno li tocca. Cosicché a causa della tua sapienzanon ti sei accorto di non avere detto nulla.
Ma dimostratemi ancora il restocioè che è possibile tacere parlando».
E a me Ctesippo sembrava preoccupato per il suo amato.
«Quando taci»chiese Eutidemo«non taci tutto?» «Sì»rispose.«Tacidunqueanche le cose che parlano se fanno
parte del tutto».
«Ma non tace tutto?»domandò Ctesippo.
«No certamente»rispose Eutidemo.
Platone Eutidemo
14
«Ma alloramio caroparla tutto?» «Le cose che parlanocerto».
«Ma non ti chiedo questo»proseguì«ma: tutte le cose tacciono oparlano?» «Nessuna delle due cose e entrambe»
ribatté Dionisodoroafferrando la parola. «So beneinfattiche nonsaprai come cavartela con la risposta».
E Ctesippocom'era solitoscoppiato in una risata fragorosadisse: «OEutidemotuo fratello ha posto l'argomento
in modo da potere dare due risposteè perduto ed è stato vinto». (85) EClinia si rallegrò molto e si mise a ridere
cosicché Ctesippo diventò più di dieci volte più grande. Ctesipposiccome è scaltroavevami sembracarpito da loro
queste sottigliezzeperché una simile sapienza non esiste fra gli altrinostri contemporanei.
Chiesi: «Perché ridiCliniadi argomenti così seri e belli?» «Socratehai mai visto una cosa bella?»domandò
Dionisodoro.
«Sì»risposi«e molteo Dionisodoro».
«Erano cose diverse dal bello o identiche ad esso?»domandò.
E io rimasi perplesso per l'aporia e ritenni di avere subito la giustapunizione per avere fiatatotuttavia risposi:
«Diverse dal bello in sétuttavia in ciascuna di esse è presente unacerta bellezza» (86) «Allora»disse«se vicino a te
c'è un buetu sei un bue eperché ora io mi trovo vicino a teseiDionisodoro?» (87) «Taci su questo»replicai io.
«Ma in che modo»chiese«una cosa diversa potrebbe essere diversaquando una cosa diversa è presente a una cosa
diversa?» «Sei forse in difficoltà su questo?»chiesi io. Ormai cercavodi imitare la sapienza dei due uominiperché la
desideravo.
«Come non essere in difficoltà»domandò«io e tutti gli altri uominisu ciò che non è?» «Che diciDionisodoro?»
chiesi. «Il bello non è bello e il brutto non è brutto?» «Se mi pare»rispose. «E ti pare?» «Certo»disse.
«Allora anche l'identico è identico e il diverso è diverso? (88) Certo ildiverso non è identicoma non avrei creduto
che neppure un bambino dubitasse che il diverso non fosse diverso.Dionisodorohai deliberatamente trascurato questo
puntoperché mi pare che anche voi per il restocome gli artigianicuicompete produrre tutti i singoli oggetti
realizziate ottimamente la dialettica». (89) «Saidunque»chiese«checosa compete a ciascun artigiano? In primo
luogo sai a chi compete lavorare dei metalli?» «Sìal fabbro».
«E costruire oggetti in terracotta?» «Al vasaio».
«E sgozzarescuoiare edopo avere fatto a pezzi le carnibollirle edarrostirle?» «Al macellaio»risposi.
«Perciò se uno fa ciò che gli competeagirà correttamente?»domandò.
«Certo».
«Conviene davverocome dicifare a pezzi e scuoiare il macellaio? (90) Haiammesso questo o no?» «L'ho
ammesso»replicai«ma compatiscimi».
«è chiaroallora»disse«che se unodopo avere sgozzato il macellaioe averlo fatto a pezzilo fa bollire e lo
arrostiscefarà ciò che è conveniente; e se qualcuno foggia il fabbro ecostruisce in terracotta il vasaioanche costui
agirà in modo conveniente».
«O Poseidone»esclamai«ormai poni un coronamento alla tua sapienza.Questa non sarà mai presente in me così
da diventare mia?» «La riconoscerestiSocrate»chiese«se fossedivenuta tua?» «Se tu lo vuoi evidentemente»risposi
io.
«Ma credi di conoscere le tue cose?»domandò.
«Se tu non dici altrimenti perché bisogna iniziare da te e finire inEutidemo qui presente». (91) «Credidunqueche
siano tue»chiese«le cose che tu dirigi e puoi usare come vuoi? Adesempio un bue e una pecora: riterresti forse tuoi
questi animali che potresti venderedonare e sacrificare a qualunque dio tuvoglia? Mentre considereresti non tuoi quelli
per i quali non è così?» E io (sapevo infatti che da quelle domandesarebbe emerso qualcosa di bello e nello stesso
tempo desideravo ascoltare al più presto): «Certo»dissi«è così:solo tali animali sono miei».
«Ma non chiami animali quegli esseri che hanno un'anima?» «Sì»risposi.
«Ammettidunqueche fra gli animali sono tuoi solo quelli riguardo aiquali hai la possibilità di fare tutto ciò che
dicevo poco fa?» «Lo ammetto». Ed eglidopo avere indugiato moltoironicamentecome se esaminasse qualcosa di
importantechiese: «DimmiSocratehai uno Zeus patrio?». E iosospettando che il discorso sarebbe arrivato dove poi
finìcercavo di sfuggire al raggiro insuperabile e mi rivoltavo già comefossi stato preso in una rete. «Non l'ho
Dionisodoro»risposi. «Allora sei un uomo infelice e non sei neppure unateniesese non hai né dèi patriiné riti sacri
né nient'altro di bello e di buono».
«Lascia stare»dissi«Dionisodorotaci e non insegnarmi con durezza.
Anch'io ho altaririti sacri domestici e patrii e tutte le altre cose diquesto tipo che hanno gli altri Ateniesi».
«Gli altri Ateniesi non hanno dunque Zeus patrio?» «Questa denominazionenon è in uso presso nessuno degli Ioni»
risposi«né presso quanti sono emigrati da questa città e neppure pressodi noiinvece Apollo è patrio a causa della
generazione di Ione. Zeus tra noi non è chiamato patrioma protettore dellafamiglia e protettore della fratria e anche
Atena è chiamata protettrice della fratria».(92) «Ma basta»disseDionisodoro; «tu haia quanto pareApolloZeus e
Atena».
«Certo»affermai. «Questidunquesarebbero tuoi dèi?»chiese.
«Fondatori della stirpe e sovrani». «Ma allora sono tuoi»disse«o nonhai ammesso che essi sono tuoi?» «L'ho
ammesso»replicai: «che cosa mi può capitare?» «Allora questi dèi sonoanche animali?»chiese.
«Già: hai ammesso che gli esseri che hanno un'anima sono animali. (93) Oquesti dèi non hanno un'anima?» «
L'hanno»risposi.
«Dunque sono anche animali?» «Animali»ribattei.
Platone Eutidemo
15
«Ma tra gli animali»disse«hai ammesso che sono tuoi quelli che puoidonarevendere e sacrificare a qualunque
dio tu voglia».
«L'ho ammesso»replicai: «non mi è possibile una ritrattazioneEutidemo».
«Via dunquedimmi subito»riprese: «poiché ammetti che Zeus è tuo egli altri dèi sono tuoipuoi forse venderli
donarli o servirti di essi come vuoicome degli altri animali?».
AlloraCritonecome colpito dal ragionamentorestai senza voce.
Ma Ctesippovenendomi in aiuto: «CaspitaEracleun bel ragionamento!»esclamò. E Dionisodoro: «Dunque
Eracle è caspita o caspita è Eracle?»chiese. E Ctesippo: «O Poseidone»esclamò«straordinari ragionamenti! Mi ritiro.
Sono invincibili questi due».
Allorao caro Critonenon ci fu nessuno tra i presenti che non lodasseoltre misura il ragionamento e i due uomini e
per poco tutti non scoppiarono dal rideredall'applaudire e dal rallegrarsi.
A ciascuno dei ragionamenti precedenti avevano applaudito in modo bellissimosolo gli ammiratori di Eutidemo
allorainveceper poco anche le colonne del Liceo non applaudirono i dueuomini e si rallegrarono. Io stesso mi trovai
in una disposizione tale da ammettere di non avere mai visto uomini cosìsapienti ecompletamente soggiogato dalla
loro sapienzali celebraili elogiai e dissi: «O voi beati per la vostrameravigliosa naturavoi che avete compiuto una
tale opera (94) così rapidamente e in poco tempo. I vostri ragionamentihanno molte altre buone qualitàEutidemo e
Dionisodoroma tra esse la più magnifica è questache non vi importanulla della maggior parte degli uominìanche di
quelli venerandi e reputatima solo di quelli simili a voi.
Infatti so bene che pochissimi uomini simili a voi potrebbero apprezzarequesti ragionamentimentre gli altri li
ignorano a tal punto che so bene che si vergognerebbero di più a confutaregli altri con tali ragionamenti che ad essere
confutati. E nei vostri ragionamenti altro elemento cortese e gentile èquesto: quando dite che nessuna cosa è bella o
buona o bianca o altro di simile o che nessuna cosa è diversa dalle altrein realtà cucite proprio le bocche degli uomini
come dite anche voi: mapoiché non cucite solo le bocche degli altrimasembrerebbe che cuciate anche le vostre
questo è molto gentile e elimina l'odiosità dei vostri discorsi. Ma laqualità più grande è che per voi queste cose stanno
così e sono state scoperte abilmentetanto che in pochissimo tempo chiunquele può imparare. Io l'ho capito anche
badando a Ctesippocon quale rapidità istantanea è stato immediatamente ingrado di imitarvi.
Dunque questa sapienza della vostra opera è bellaperché si trasmetterapidamentema non è adatta per discutere
davanti alla gentema se mi date rettavi guarderete dal parlare davanti amolte personeper evitare chedopo avere
imparato rapidamentenon vi ringrazino neppure.
Ma soprattutto discutete tra voi due soli; altrimenti se discutete davanti aqualcun altrofatelo solo davanti a uno che
vi dia del denaro. Ese siete saggidarete anche ai vostri discepoli questistessi consiglidi non discutere mai con
nessunoma con voi o tra loroperché ciò che è raroEutidemoèpreziosoinvece l'acqua è a poco prezzopur essendo
ottimacome disse Pindaro. (95) Ma orsù»dissi«accettate anche me eClinia qui presente». (96) Dopo avere discusso
di queste cose e di poche altre ancorao Critonece ne andammo. Cercadunquedi frequentare insieme a noi la scuola
di quei due uominipoiché dicono di essere capaci di insegnare a chi vogliadare loro denaro e che né la naturané l'età
impediscano e - cosa che a te soprattutto conviene ascoltaredicono che nonimpediscano neppure di accumulare
ricchezze (97) - che chiunque impari facilmente la loro sapienza.
CRITONE: Socratesono veramente desideroso di sentire e imparerei volentieriqualcosama c'è il rischio che
anch'io sia uno di quelli che non assomigliano ad Eutidemoma sia di quellidi cui anche tu parlaviche preferirebbero
essere confutati da ragionamenti simili piuttosto che confutare. Mi sembraridicolo ammonirtituttavia voglio riferirti
ciò che ho sentito. Sappi che uno di quelli che se ne andavano dalla vostrariunioneun uomo considerato molto
sapienteuno di quelli esperti nei discorsi per i tribunali(98)avvicinatosi a me che passeggiavomi chiese: «Critone
non ascolti nulla di ciò che dicono questi sapienti?» «Noper Zeus»risposi«perché non sono davvero riuscitopur
essendomi avvicinatoad ascoltarea causa della folla».
«Eppure»disse«valeva la pena sentire».
«Perché?»domandai.
«Per sentire discutere uomini che ora sono i più sapienti tra quelli che sioccupano di tali ragionamenti».
E io chiesi: «Che cosa ti sembrarono?» «Che cos'altro»rispose«se nondi avere ascoltato cose che si potrebbero
sempre sentire da tali uomini che parlano stoltamente e che si prendono unacura immeritata di cose che non valgono
nulla?».
(Si espresse press'a poco con queste parole).
E io: «Ma peraltro»dissi«la filosofia è una cosa gradevole».
«Come gradevole»domandò«o caro? Non vale nulla. Maanche se tu orafossi stato presentecredo che ti saresti
vergognato molto del tuo amico: era così stolto quando voleva affidarsi auomini ai quali non importa nulla di ciò che
diconoma che si attaccano ad ogni frase. E questicome dicevo poco fasono i migliori tra i nostri contemporanei. Ma
o Critone»concluse«questa attività e gli uomini che se ne occupanosono sciocchi e ridicoli». Ma a meSocrate
sembrava che non biasimassero giustamente questa attività né costui néchiunque altro la denigrasse.
Tuttavia mi pareva che rimproverasse a ragione il volere discutere con talipersone davanti a molta gente.
SOCRATE: O Critonetali uomini sono meravigliosi. Ma non so ancora che cosadevo dirne. Quello che si avvicinò
a te e biasimò la filosofia di che categoria di uomini faceva parte? Eraforse di quelli che sono abili a contendere nei
tribunaliun retoreo di quelli che mandano in tribunale gli oratoriuncompositore di discorsicon i quali i retori
dibattono le cause? (99) CRITONE: Per Zeusnon era affatto un retore e credoche non si sia mai presentato in
Platone Eutidemo
16
tribunalema dicono che sia esperto della materiaper Zeuse sia abile ecomponga abili discorsi.
SOCRATE: Ora capisco: anch'io poco fa volevo parlare di costoro.
Questi sonoinfattio Critonequelli che Prodico definì a metà stradatra il filosofo e il politicoma credono di
essere i più sapienti di tutti gli uominie oltre ad esserloanche disembrare molto sapienti a giudizio di molti; cosicché
al godere di buona reputazione presso tutti non sono loro di impedimentoaltri che gli uomini che si occupano della
filosofia. Ritengonodunquechese riusciranno a produrre l'opinione chequesti non valgano nullaormai davanti a
tutti riceveranno sicuramente il premio della vittoria nella fama disapienza. Infatti credono di essere veramente
sapientissimima quando vengono intralciati nelle conversazioni privatecredono di essere rovinati dai seguaci di
Eutidemo. Credono di essere molto sapienti - a buon diritto perché ritengonodi occuparsi con misura di filosofia e con
misura di pubblici affaricon un ragionamento molto verisimile - e dipartecipare di entrambe le attività quanto è
necessario e di godere della sapienzastando al riparo da pericoli e lotte.
CRITONE: MaSocrateti sembra che abbiano ragione? Perché veramente ilragionamento di questi uomini ha una
bella apparenza.
SOCRATE: Eo Critoneha veramente una bella apparenza più che verità.Infatti non è facile convincerli che gli
uomini e tutte le cose che sono intermedie tra due realtà e che partecipanodi entrambe: quelle che sono composte di una
cosa cattiva e una cosa buona diventano migliori dell'una e peggioridell'altra; quelle composte di due cose buone non
relative allo stesso fine diventano peggiori di entrambe in relazione al fineper il quale è utile ciascuna delle due di
quelle da cui sono formate; quelle che sono composte di due cose cattive nonrelative allo stesso fine stanno nel mezzo:
queste sole sono migliori di ciascuna di quelle di entrambe le qualipartecipano. Sedunquela filosofia è una cosa
buona e anche l'attività politica lo èma ciascuna in relazione a un finediversoe costoro che partecipano di entrambe
stanno nel mezzo di questesbagliano perché sono inferiori ad entrambe; sesono una buona e l'altra cattiva sono
migliori dell'una e peggiori dell'altra: seinvecesono entrambe cattivein tal caso e in nessun altrodirebbero qualcosa
di vero. Certamente io non credo che essi possano ammettere né che entrambesiano cattive né che l'una sia cattiva e
l'altra buona; ma in realtà costoropartecipando di entrambesonoinferiori ad entrambein relazione a ciascun fine per
il quale la politica e la filosofia sono degne di considerazione edessendoterzi in veritàcercano di sembrare primi.
Bisognadunqueperdonarli per il loro desiderio e non irritarsimaconsiderarli quali sono. Infatti bisogna amare ogni
uomochiunque siae qualunque cosa dica che sia intelligente e si impegni afondo con coraggio per compierla.
CRITONE: Anch'ioo Socrateriguardo ai miei figli(100) come ti dicosempresono in difficoltà su che cosa devo
farne. L'unoinfattiè ancora alquanto giovane e piccoloCritobuloinveceè già adulto ed ha bisogno di qualcuno che
lo aiuti. Ioquando sono con temi trovo in una disposizione tale che misembra una follia l'avere avuto tanta premura
di molte altre cose per i miei figlisia riguardo al matrimonioaffinchénascessero da una madre nobilissimasia
riguardo alle ricchezzeaffinché fossero il più possibile ricchima averetrascurato la loro educazione. Ma quando
guardo qualcuno di quelli che professano di potere educare gli uominirimango costernato e a me che li esamino
sembra che ognuno di essi sia molto stranoper dirti la verità; cosicchénon so come volgere il giovinetto alla filosofia.
SOCRATE: O caro Critonenon sai che in ogni occupazione gli uomini inettiche non valgono nulla sono molti
mentre le persone serie e degne di gran conto sono poche? Dunque laginnastica non ti sembra una bella occupazione e
così la crematisticala retorica e la strategia?
CRITONE: Sìcertamente.
SOCRATE: Ma non vedi che in ciascuna di queste occupazioni i più sonoridicoli relativamente a ciascuna opera?
CRITONE: Sìper Zeusdici proprio la verità.
SOCRATE: Per questo motivo eviterai forse tu stesso tutte le occupazioni enon vi rivolgerai tuo figlio?
CRITONE: Non sarebbe giustoo Socrate.
SOCRATE: Allora non fare ciò che non bisogna fareo Critonema dopo averedato l'addio a quelli che si occupano
di filosofiasia che siano buoni sia che siano cattivie dopo avereesaminato molto bene la cosa stessase ti sembra di
poco contodistogli da essa ogni uomonon solo i tuoi figli; seinvecetisembra quale io credo che siaseguila e
praticala con coraggiocome si dicetu stesso e i tuoi figli.
Platone Eutidemo
17
NOTE: 1) Critoneamico e coetaneo di Socratedel suo stesso demoera ildiscepolo più anziano del filosofo.
Compare in vari dialoghi platonici come CritoneFedoneEutidemo. SecondoDiogene Laerziolibro 2121avrebbe
scritto diciassette dialoghi.
2) Il Liceo eracon l'Accademia e il Cinosargeuno dei tre grandi ginnasidi Atene fondati nel sesto secolo a.C. Era
situato a nord-est della cittàfuori le muraai piedi del Licabetto esulla riva destra dell'Ilisso.
3) Il figlio di Assioco è Cliniaun giovane aristocraticocugino delfamoso Alcibiade e amico di Socrate.
4) Critobulo era figlio di Critone: su di lui cfr. la Premessa.
5) Alcuni riferiscono i pronomi "écheinos" e "outos"rispettivamente a Clinia e a Critobulo; per altri i riferimenti
sono invertiti. Dal punto di vista grammaticale è più probabile la primainterpretazione.
6) Si è molto discusso sulla realtà storica di Eutidemo e Dionisodoro.
Alcuni ritengono che due sofisti con questi nomi siano realmente esistitimache Platone abbia costruito i suoi
personaggi con notevole libertà.
Sembra infatti che essi fossero originari di Chio e che insieme a molti altriloro concittadini avessero seguito un
gruppo di ateniesi emigrati a Turida dove però erano stati banditi e sierano trasferiti in Grecia.
Eutidemo è citato anche nel Cratilo (386d) come sostenitore della tesi cheper tutti tutte le cose sono allo stesso
modo insieme e sempre.
Aristotele (Sophistici elenchi 20177b 12 seguenti; Rhetorica libro 2241401a 24 seguenti) riporta un suo sofisma
non presente in questo dialogo.
Dionisodoro è ricordato da Senofonte (Memorabilia libro 311) come maestrodi strategia.
7) In questo dialogo "sophia" è usato nel senso di 'abilità''competenza tecnica' specificapiù che nel senso di
'saggezza di vita'.
8) Una delle Sporadivicino alle coste dell'Asia Minoretra Lesbo e Samo.
9) Colonia panellenica fondata nel 444 a.C. in Magna Greciapresso il golfodi Tarantoda un gruppo di ateniesi e
loro alleatinel luogo in cui sorgeva la distrutta Sibari.
10) Il pancrazio era una gara che comprendeva lotta e pugilato. Platone giocasull'etimologia della parola che
interpreta come 'capacità di vincere tutti'.
11) Altrimenti ignoti.
12) Il cittadino ateniese in tribunale doveva difendersi da solo. Se non erain grado di farlodoveva rivolgersi a un
logografo il qualedietro compensoscriveva per lui un discorso da leggeredavanti ai giudici.
13) Per l'eristicae la sua confutazione da parte di Platonesi veda ilLiside.
14) Conno era un noto maestro di musica ateniesepiù volte irriso daicomici. Frinico e Amipsia avevano composto
ognuno una commedia intitolata Conno.
15) è il noto "daimon" di Socrate: cfr. PlatoneApologia Socratis31d; Euthyphro 3b; Theaetetus 151aeccetera 16)
Il "catástegos drómos" era una specie di 'tribuna coperta' inlegnocostruita di fianco alla palestradove ci si poteva
intrattenere a conversare.
17) Ctesippo era cugino di Menessenoamico di Clinia e discepolo di Socrate.
Compare anche tra i personaggi del Liside (203a) e viene nominato nel Fedone(59b) tra gli amici che hanno
assistito alla morte di Socrate.
18) Peania era un demo dell'Atticaa est di Atene: vi nacque Demostene.
19) Il Gran Re era il re di Persia.
20)Socrate domanda ai due eristi se essi posseggono l'arte protrettica.
Il primo esempio di letteratura protrettica dell'antichità èprobabilmenteproprio l'Eutidemo di Platone.
21) Alcibiade il Vecchio ebbe due figli: unoCliniamorì a Cheronea nel447 a.C. e lasciò due figliil maggiore dei
quali fu il famoso Alcibiade; l'altroAssiocofu padre del giovane Cliniache compare in questo dialogo. A questo
Assioco è dedicato l'omonimo dialogo pseudoplatonico.
22) Le Muse erano figlie di Mnemosine. In una civiltà letteraria che permolto tempo restò esclusivamente o
prevalentemente oralela memorizzazione aveva importanza primaria.
23) Il sofisma si basa sul duplice significato dei termini "sophós"('sapiente' e 'persona intelligente')"amathés"
('ignorante' e 'stupido')"manthánein" ('imparare' e 'comprendere').Si svolge in due tempi: dapprima Clinia è indotto da
Eutidemo ad ammetterecontrariamente a quanto aveva sostenuto in precedenzache apprendono gli ignoranti e poi da
Dionisodoro a riaffermare che apprendono i sapienti.
24) Il "grammatistés" era il maestro di scuolache insegnava aleggere e a scrivere.
25) Il termine "érastes" significa qui 'ammiratore fanatico di unmaestro'.
26) Allusione poco chiara ad una figura della danza antica.
27) Il sofisma si fonda sul duplice significato del verbo "manthánein"('imparare' e 'apprendere') e si svolge in due
tempi: dapprima Clinia è spinto da Eutidemo ad ammetterecontrariamente aciò che aveva detto in precedenzache
coloro che imparano imparano ciò che sanno e poi da Dionisodoro ariaffermare che coloro che imparano imparano ciò
che non sanno. Lo schema seguito è identico a quello del sofisma precedente.
28) Nella lotta vinceva chi riusciva ad atterrare per tre volte l'avversario.
29) La "thrónosis" ('intronizzazione') era la cerimonia cheprecedeva l'iniziazione ai misteri. L'iniziando sedeva su
un trono sacromentre i Coribantisacerdoti delle dea frigia Cibeledanzavano e cantavano intorno ad esso.
30) Prodico nacque a Ceo tra il 470 e il 460. Svolse diversi incarichidiplomatici per la sua città e si recò più volte
Platone Eutidemo
18
anche ad Atenedove tenne con successo conferenze e impartì lezioni aigiovani borghesi e nobiliall'inizio della guerra
del Peloponneso. Furono suoi discepoli EuripideIsocrate e forse Socrate.Scrisse un'opera dal titolo "Oras"di cui
dovevano fare parte i trattati Sulla natura e Sulla natura dell'uomo.
In essa celebrava come madre di tutte le attività l'agricolturaalla qualelegava anche le origini della religione.
Platone lo ricorda spesso per i suoi studi di sinonimia.
31) "Idiótes" è chi non possiede una "techne" ed èquindi incompetente in essa.
32) Nel linguaggio corrente "eu práttein" significa 'averesuccesso''stare bene'ma Platone intende "eu"nl senso di
"orthos"conferendo in tal modo a "eu práttein" ilsignificato di 'agire correttamente'. Egli giunge così alla conclusione
che il successo consista nell'azione corretta.
Ma solo chi sa può compiere un'azione corretta. Viene allora giustificatal'identificazione tra "sapere" e "successo":
la sapienza è condizione essenziale della felicità.
33) Esistevano due tipi di atimia: uno più graveche implicava la perditadelle capacità giuridichela confisca dei
beni e l'esilio; un altro meno graveche implicava la perdita dei dirittipubblicima non di quelli privati.
34) Il problema se la sapienza o la virtù possano essere insegnate vienedibattuto nel Protagora e nel Menone.
35) Il sofisma si fonda sull'interpretazione del pronome relativo "os"nel senso di "oios" ('quale') e sul duplice
significato del verbo "einai" ('essere' ed 'esistere'). Ildesiderio di un mutamento delle qualità di Clinia viene identificato
col desiderio di un mutamento della sua esistenzaossia della sua morte.
36) è sembrato ad alcuni che nella tesi sostenuta da Eutidemonel suosottintendere che la realtà della cosa e la
realtà della parola siano identichesi possa ravvisare la tesi di Antistene.
37) L'espressione "cacos léghein" può essere interpretata siacome 'dire male di' sia come 'dire in modo inesatto'.
38) Il termine "psuchrós" aveva sia il significato di 'freddo''insensibile''indifferente' sia quello offensivo di
'insignificante'.
39) I Cariiun popolo dell'Asia Minorei cui membri si arruolavano spessocome mercenari negli eserciti stranieri
erano ritenuti nell'antichità uomini senza valore.
40) Nella tragedia euripidea Peliadirappresentata nel 455 a.C. e oggiperdutaveniva narrata la vendetta di Medea
nei confronti di Peliasovrano di Iolcocolpevole di avere ucciso ilproprio fratellastro Esone con suo figlio Promaco e
di avere mandato Giasone alla conquista del vello d'oro. La maga per ottenereil suo scopo aveva spinto con l'inganno le
figlie del re a fare a pezzi il loro padre e a cuocerlopromettendo che poigrazie alle sue arti magichelo avrebbe fatto
tornare in vita non più vecchioma giovane. In seguitoperònon avevapronunciato le parole magiche e le figiie di
Peliainorridite per il delitto compiutosi erano recate in esiliovolontario in Arcadia (cfr. EuripideMedea 434-487).
41) Il sileno frigio Marsiacantore e flautistaaveva sfidato Apollocitarista a una garama era stato sconfitto. Il dio
lo aveva quindi punito per il suo ardirescorticandolo vivo ed avevafabbricato con la sua pelle un otreche Erodoto
(libro 726) dice di avere visto appeso in una piazza di Celenein Frigia.
42) L'impossibilità del contraddire era sostenuta da Antistenecometestimonia AristoteleTopica libro 111104b
20.
43) Se due persone pensano e parlano di una stessa cosa Xallora concordano;seinveceuno dei due ha una
nozione falsa di Xallora non parla di Xbensì di Y; seinfineentrambihanno una nozione falsa di Xallora uno pensa
a Yl'altro a Ze nessuno a X cosicché non si contraddicono.
44) è qui presente un accenno alle Antilogìe di Protagorain cui ilfilosofo partiva dal presupposto che l'uomo fosse
misura di tutte le cosedi quelle che sono in quanto sono e di quelle chenon sono in quanto non sono e che quindi il
reale fosse inafferrabileper giungere alla conclusione cheù pur essendodue tesi tra loro contraddittoriel'una poteva
essere vera quanto l'altra. Protagora di Abdera nacque intorno al 486 a.C.Verso il 444 si recò ad Atenedove conobbe
Pericleche probabilmente gli affidò l'incarico di preparare un codice dileggi per la colonia panellenica di Turi. Tornò
spesso nella città attica. L'ultima volta che vi mise piede fu nel 411quando Pitodoro di Polizelouno dei Quattrocento
lo accusò di empietàa causa delle affermazioni contenute nella sua operaSugli dèi.
Nello stesso anno si allontanò da Atene e morì in un naufragio. Composeoltre alle opere citateAntilogie e Sugli
dèianche uno scritto dai titolo La Verità o Discorsi demolitori.
45) Si tratta probabilmente dei membri della scuola eleatica (Zenone eParmenide)dalla cui tesi che l'essere è e il
non essere non è si poteva dedurre l'impossibilità di dire ciò che non ècioè il falso e di contraddire.
46) Nel testo greco il termine è "Krónos" Cronoil padre diZeusspodestato dal figliosimboleggia un mondo
ormai passatosuperato; in senso traslato Kronos significa quindi 'vecchio''antiquato''rimbambito".
Cfr. AristofaneNubes 929; Vespae 1450; Plutus 581.
47) Il sofisma si fonda sul duplice significato del verbo "noein"('pensare' e 'avere senso').
48) Ctesippo si rivolge ironicamente ai due eristi con una formula utilizzatadai poeti per invocare gli dèi
accennando ai loro numerosi attributi.
49) Proteo era una divinità marina che conosceva il passato e il futuro eviveva spesso sull'isola di Farovicino alla
foce del Nilo. Aveva la capacità di trasformarsi nei modi più vari (di quil'italiano "proteiforme") e la sfruttava per
evitare di dovere profetizzare. Su consiglio della figlia del diola ninfaIdoteaMenelao lo aveva interrogato e
nonostante tutte le sue metamorfosinon lo aveva lasciato scappatefinchénon aveva ottenuto una risposta. Cfr. Omero
Odyssea libro 4349-570.
50) Menelaosecondo la versione fornita dall'Iliadeera figlio di Atreoredi Micene e apparteneva alla stirpe di
Pelope. Era fratello di Agamennone e marito di Elena.
Platone Eutidemo
19
51) La crematistica è l'arte di fare quattrini (da "krema" 'denaro').
52) Forse si fa riferimento ad Isocrate.
53) Probabile allusione all'oratore e sofista Trasimaco di Calcedonia (quintosecolo a.C.).
54) Mentre nel Menone il termine "dialettico" indica chi sacondurre una discussionequi indica chi sa cogiiere la
struttura dialettica del tutto.
55) In Grecia era diffuso l'uso di allevare le quagliedestinate acombattere fra loro. Ad Atene questo divertimento
era degenerato in una vera e propria maniache contendeva il primato allapassione per il combattimento dei galli.
56) Esseri superiori possono essere dèi o demonima evidentemente Critonepensa a Socrate.
57) In Eschilo (Septem 2-3) Eteocle dice: «Chi attende al suo compitoallapoppa della cittàtenendo in mano il
timonesenza lasciare che il sonno gli faccia calare le palpebre...».
58) Critone era un proprietario terriero.
59) Il proverbio sta ad indicare qualcosa che si ripete spesso e inutilmente.
Durante una guerra tra Corinto e Megara (o Corcira) i Corinzi avevano inviatoai nemici un araldo che ripeteva loro
continuamente: «Corintofiglio di Zeusnon vi lascerà in pace; Corintofiglio di Zeusvi perseguiterà»finché questi
irritatilo avevano scacciato (cfr. PindaroNemea libro 7154-155).Corinto era considerato l'eroe eponimo e il primo
re della città.
60) I DioscuriCastore e Polluceerano numi protettori dei marinai durantele tempeste.
61) La terza ondata era considerata la più violenta e pericolosa.
La richiesta di aiuto nel momento dell'aporia viene ironicamente paragonataad un'invocazione agli dèi.
62) Il sofisma consiste nel dare all'espressione "epístasai ti"('sai qualcosa')intesa in senso relativoil valore
assoluto di "epistémon einai" ('essere sapiente').
63) "Phíle kephalé" letteralmente significa 'diletto capo' ed èespressione omericausata poi anche dai tragici.
64) Ctesippo allude ironicamente all'età avanzata dei due fratellicheprobabilmentenon avevano più denti.
65) Socratenel tentativo di rendere più precisa la questioneprovocal'ira di Eutidemo.
66) Il sofisma è basato sul duplice significato di "aeí":'sempre' e 'in ogni occasione'.
67) Il sofisma si fonda sulla duplice interpretazione che in questo contestopuò essere data a "pánta" ('tutto' quello
che so e 'tutto' quello che è possibile sapere) e sulla distinzione tra"apanta" ('tutto nel suo insieme') e "páanta"
('ciascuna cosa').
68) L'espressionedi solito rivolta agli dèiè qui usata in sensoironico.
69) Allusione al detto "contro due neppure Eracle ce la può fare".Esso fa riferimento a una delle fatiche dell'eroela
lotta contro l'idra di Lernaun serpente con molte testeuna delle qualiimmortale. Mentre combatteva con il mostroil
semidio era stato assalito da un enorme granchioinviato contro di lui daErache lo aveva morso ad un piede. Egli
aveva ucciso il crostaceoma poi era stato costrettoper sconfiggerel'idraa chiedere aiuto al nipote Iolaofiglio del
fratellastro Ificledal momento che al posto di ogni testa da lui tagliatane ricrescevano sempre altre due nuove.
Iolao era riuscito ad impedire la ricrescita delle testebruciando contizzoni ardenti le ferite del serpente. Eracle
aveva così potuto ucciderlorecidendogli anche la testa immortale che avevapoi seppellito.
L'idra rappresenta Eutidemodi cui non si riescono a interrompere iragionamentimentre il granchio rappresenta
Dionisodoroche viene da sinistra e dà colpi bassi.
70) Accenno ai due eristiapprodati da poco ad Atene.
71) Pare che Palrocledi cui abbiamo notizia solo in questo passofossefiglio di Fenarete e di Cheredemoe perciò
fratellastro di Socratei cui genitori erano Fenarete e Sofronisco.
72) Ificlefiglio di Alcmena e Anfitrioneera fratellastro di Eradenatoda Alcmena e Zeus.
73) Il sofisma si fonda sul fatto che il termine "patér" vieneinteso come una caratteristica riferibile non a più
personema ad un solo individuo.
74) Metti insieme cose che insieme non possono stare.
75) Il sofisma si basa sull'attribuzione di un senso assoluto all'aggettivo"sós" 'tuo'la quale permette di riferirlo sia a
cane sia a padre.
76) L'elleboro era considerato una pianta medicinale in grado di curare lafollia.
77) Si tratta probabilmente della statua di Apollo che tiene in mano ilrostro di una navededicata al dio dopo la
vittoria di Salamina contro i Persiani. Secondo Erodotolibro 8121eraalta più di cinque metri.
78) Giganti dalle molte braccia.
79) L'espressione "echein en aúto" può significare sia 'avere insé' sia 'avere su di sè'.
80) Il talento ateniese che come peso equivaleva all'incirca a 50 chilicorrispondeva a 60 mine. Chi aveva un
patrimonio di un talento era ritenuto benestante.
81) o statere era una moneta d'oro che pesava poco più di 8 grammi.
82) SecondO Erodotolibro 465 gli Sciti erano soliti pulire l'interno deicrani dei nemici uccisi per servirsi di essi
come coppe; i ricchi ne facevano dorare l'interno. Qui "éauton" ('loro')può essere inteso in due modiper cui si può
equivocare tra i crani dei nemici che gli Sciti posseggono e i crani degliSciti stessi.
83) Il sofisma si fonda sul duplice significato dell'espressione "tadunata oran": 'le cose che si possono vedere' e 'le
cose che possono vedere'.
84) L'espressione "sigonta léghein" vale sia 'parlare tacendo' sia'parlare di cose che tacciono'. Così anche
l'espressione "légonta sigan" significa sia 'tacere parlando' sia'tacere di cose che parlano'.
Platone Eutidemo
20
85) Dionosodororispondendo in modo ambiguoha infranto la regola propriadell'eristica del rispondere sì o no.
Cfr. l'analogO rimprovero mosso da Eutidemo a Dionisodoro (297a).
86) Evidente l'allusione alla dottrina delle idee.
87) Probabile un riferimento alla teoria di Antistene che consideravacorretti solo i giudizi di identità.
88) Socrateimitando i due eristigioca sul significato di"diverso".
89) "Tò dialéghesthai" si può tradurre con 'la dialettica'.
90) Il sofisma si basa sul fatto che "mágheiron" ('macellaio')può fungere sia da soggetto sia da oggetto di
"kátakoptein" ('fare a pezzi') e "ekdérein" ('scuoiare').
91) è qui usata ironicamente una formula di cui i poeti si servono percelebrare gli dèi.
92) Gli Ateniesi chiamavano "patros" ('padre della stirpe') nonZeusma Apolloperché lo ritenevano genitore di
Ioneloro antenato eponimo (cfr. EuripideIon 64-75). Zeus e Atenainveceerano detti "phrátrioi"cioè 'protettori
delle fratrie'raggruppamenti di genti che si attribuivano un'originecomunefraterna.
93) Dionisodoro gioca sul duplice significato del termine "zoon":'essere vivente' e 'animale'.
94) è l'eristica.
95) Cfr. PindaroOlympica 11.
96) Il passo esprime in modo esemplare il tema centrale del dialogo: la beffasulla saggezza.
97) Critone si occupava di affaridei propri campi.
98)L'identità di questo personaggio è discussa: i più ritengono che sitratti di Isocratecontemporaneo di Platone
sostenitore della retorica come paideia alternativa a quella data dallafilosofia; altri identificano il personaggio con il
retore Antifonte.
99) Il retore che pronuncia discorsi in pubblico dinanzi a una assemblea o aun tribunale viene contrapposto al
logografo che li compone.
100) Secondo Diogene Laerziolibro 213Critone ebbe quattro figli:CritobuloErmogeneEpigeneCtesippotutti
discepoli di Socrate.